
da Valentina Venturi | 10 Nov, 2023 | Difesa Foreste
Il Gruppo Unitario per le Foreste Italiane prende atto delle gravi parole del Sindaco di Altavilla Silentina apparse in virgolettato sul Corriere di Mezzogiorno del 9 Novembre. Non corrisponde al vero che l’intenzione del Comune sia quella di diradare il bosco Chianca: il bosco infatti sta venendo tagliato a raso. Non è vero che le ragioni per cui il bosco sta venendo tagliato siano inerenti al suo stato fitosanitario, per la presenza di piante “marce” (sic!). Il Sindaco tenta di strumentalizzare la risposta della Regione Campania a questo Gruppo, che concerne solamente aspetti interpretativi della normativa, e che anzi ribadisce la possibilità che il bosco possa essere tagliato a raso, come previsto dal piano di assestamento, che tuttavia è ormai scaduto. A tale lettera della Regione abbiamo prontamente risposto, confutando nel merito le ragioni di diritto ivi esposte, ritenendole gravemente inesatte. Sottolineiamo inoltre che il taglio del bosco ha già prodotto rapporti giuridici di natura economica tra il Comune, il tecnico pagato 16 mila euro, e la ditta boschiva che ha sborsato 200 mila euro non certo per eseguire tagli fitosanitari.
I tagli per ragioni sanitarie e i diradamenti, infatti, hanno una procedura di legge completamente diversa dalle comunicazioni formali inoltrate dal Comune alla Regione, che in questo caso concernono esclusivamente il taglio del bosco a fini economici. In nessun caso, nella missiva della Regione, si fa riferimento a diradamenti, né a problemi fitosanitari, quindi è totalmente fuorviante lasciar credere che le ragioni del taglio siano quelle addotte dal Sindaco.
Questo Gruppo ha piuttosto sostenuto sin dall’inizio come il bosco di Chianca, utilizzato a ceduo fino a 45 anni fa, sia adesso divenuto strutturalmente una fustaia, anche da un punto di vista legislativo, e che l’unico intervento ammissibile sia, appunto, l’intervento di diradamento che il Sindaco usa a sproposito, aggravando le sue dichiarazioni con riferimenti alla possibilità che il bosco, se non tagliato, muoia. Questa tesi è ampiamente smentita dalla scienza. Le foreste esistono sul pianeta da circa 350 milioni di anni, mentre l’essere umano ha fatto la sua comparsa circa 400mila anni fa. Prima dell’arrivo della nostra specie, le foreste coprivano gran parte delle terre emerse, e per merito delle nostre azioni si sono drasticamente ridotte. È quindi lapalissiano che il bosco non ha alcun bisogno dell’uomo e delle sue motoseghe per sopravvivere e prosperare, ma migliora invece in struttura e complessità quando l’uomo smette di tagliare gli alberi e lo lascia alle sue dinamiche evolutive naturali.
Esprimiamo inoltre il nostro sconcerto per quanto detto sulla fauna selvatica: secondo quanto riferito dai cittadini presenti all’assemblea di ieri sera, la giunta avrebbe, incredibilmente, sostenuto che “nel bosco non ci sono animali”. Affermazione assolutamente assurda per qualsiasi ambiente naturale, ma resa ancora più comica dalla vicinanza dell’area al Parco Nazionale del Cilento.
Riteniamo che il rapporto di fiducia tra il Sindaco e i suoi cittadini si sia irreparabilmente rotto, e invitiamo pertanto il primo cittadino di Altavilla Silentina a chiedere scusa alla cittadinanza e a rimettere il suo mandato.
Noi, nel frattempo, continueremo ad informare l’opinione pubblica, i cittadini di Altavilla Silentina e gli organi di controllo circa questa vicenda sempre meno chiara, mossi esclusivamente dalla necessità di salvaguardare il patrimonio boschivo, soprattutto in questo periodo storico di crisi climatica in cui gli ecosistemi forestali sono i nostri più importanti alleati.

da Valentina Venturi | 29 Set, 2023 | Foreste
29 settembre 2023 – È stato approvato, in sede di conversione del Decreto legge “Asset” che trattava di tutt’altra materia, un emendamento presentato da FdI che cancella totalmente la tutela paesaggistica dei boschi nei confronti dei tagli boschivi, manomettendo il Codice Urbani e il senso originario della legge Galasso: la tutela dei boschi nelle aree vincolate con decreto ed il concetto di taglio colturale.
La difesa dei boschi ha subito, negli anni, vari attacchi del mondo forestale, sia da parte delle ditte, che dei politici degli enti locali, che di alcune rappresentanze dei dottori agronomi e forestali, che di una frazione del settore accademico, contro il parere prevalente di biologi, botanici e studiosi dell’ecologia e del paesaggio.
Le regioni, in modo incontrollato, hanno esteso il concetto di taglio colturale ad ogni possibile ed immaginabile trattamento selvicolturale, anche il taglio a raso, che si applica ai nostri boschi ceduo. Il motivo questa volta è chiaro, come dice letteralmente l’art. 5–bis del decreto, senza tanti giri di parole: incentivare la filiera del legno, aumentare la concorrenza sui mercati esteri (specialmente quelli balcanici e nord europei, che tagliano boschi a raso su grandi superfici) e accrescere l’approvvigionamento interno di legno, rallentando l’evoluzione degli ecosistemi forestali. Si annulla quindi la tutela paesaggistica, di rango costituzionale primario, al fine di incrementare l’economia. Del resto, non è la prima volta che principi costituzionali vengono violati pur di aumentare i tagli boschivi: pensiamo per esempio al Testo Unico per le Filiere Forestali, che consente alle Regioni di obbligare i proprietari a tagliare i loro boschi.
Questo la dice lunga non solo sull’attuale politica di tutela ambientale e dei beni culturali, ma sulla stessa cultura costituzionale, tra l’altro recentemente arricchita dalla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della biodiversità, gravemente fraintesa da chi ha proposto e votato questo articolo. Una scelta del tutto anticostituzionale.
Questa non vuole essere una critica politica all’attuale maggioranza, visto che tale volontà politica, che covava dal 2018, anno di approvazione del controverso Testo Unico Forestale, è trasversale ai maggiori partiti, con asse privilegiato PD-Lega, cui si è aggiunta anche FdI.
Dietro questa decisione ci sono molte lacune culturali, scientifiche e concettuali da parte dei proponenti, nonché palesi ragionamenti illogici e aberranti tra i sostenitori, la cui applicazione apre allo smantellamento di ogni tutela ambientale e paesaggistica.
Innanzi tutto da parte di coloro che sostengono che l’opera dell’uomo ha formato il paesaggio, e quindi anche i tagli, in quanto opera dell’uomo, fanno parte del paesaggio. Con questo ragionamento, potremmo sostenere che anche le case e i palazzi fanno parte delle opere umane, e quindi costruire qualsiasi casa o palazzo non danneggi mai il paesaggio.
Chi sostiene poi che l’autorizzazione paesaggistica danneggi l’economia forestale in quanto inutile orpello burocratico, ammette di conseguenza, con tale ragionamento, che anche l’autorizzazione paesaggistica per costruzioni, apertura di cave, e ogni altra opera, essendo oggettivamente un orpello alle attività produttive, potrà essere superata a richiesta degli operatori e dei professionisti del settore (imprese edili, ingegneri, architetti, che invece non si sognano nemmeno lontanamente di farlo).
Il prossimo passo sarà quindi, conseguentemente e coerentemente, l’abrogazione dell’art. 9 della Costituzione?
Adesso finalmente parte del settore dei tagliatori e dei dottori forestali avrà mani libere sui boschi che, coi loro 11 milioni di ettari, rappresentano il più vasto patrimonio culturale della nazione.
Con il presente comunicato lanciamo pertanto l’appello a tutte le associazioni di protezione ambientale, ai comitati, ai gruppi di azione civica e ai cittadini, affinché la protesta della società civile si elevi sopra questa barbarie.

da Valentina Venturi | 16 Ago, 2023 | Difesa Foreste, Foreste, Piano AIB
Pubblichiamo di seguito la lettera ricevuta dal Professor Franco Pedrotti, luminare della botanica:
“L’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise ha preso la decisione di effettuare un
taglio di pini nella pineta di Villetta Barrea.
Viene subito da dire che un parco nazionale ha per scopo quello di proteggere gli alberi e non di
tagliarli. La pineta di Villetta Barrea è un bosco residuo e relitto, di grande interesse fitogeografico,
poiché rappresenta l’ultimo frammento di una pineta che in passato era molto diffusa in tutto
l’Appennino centrale, come risulta dalle analisi polliniche eseguite.
In un Parco Nazionale si dovrebbero sempre prevedere alcune aree ove il bosco è lasciato al suo
libero sviluppo, in modo da raggiungere la fase ecologica della fluttuazione. In questo caso gli
alberi completano nello stesso punto il loro ciclo vitale, dal seme alla vetustà. Questa forma di
gestione dovrebbe essere applicata anche alla pineta di Villetta Barrea.
Si può anche pensare a una forma di gestione più articolata della pineta, sempre che non comporti
l’eliminazione di porzioni della stessa. In nessun caso è ammissibile il taglio, né lo sfoltimento
giustificato da prevenzione incendio.
La prevenzione incendio va fatta utilizzando uomini e mezzi adeguati che non prevedano la
distruzione o la manomissione del bosco, altrimenti distruggiamo ciò che invece vorremmo tutelare.
Si chiede pertanto che il Parco voglia ripensare e sospendere definitivamente questa insensata
decisione, ancor più che questa pineta rappresenta un alto valore ecologico, storico, culturale e botanico.
Essa mostra una importante rinnovazione di pino e latifoglie, nonché una struttura forestale ormai
notevole. Questa pineta è importante anche per la stabilità idrogeologica e per la biodiversità,
racchiudendo specie di piante non comuni (es.: Orthilia secunda).
Essa incarna anche un alto valore da un punto di vista forestale, in quanto essa rappresenta l’opera
dei forestali e la pineta madre dei rimboschimenti realizzati in Italia centrale.
Professore Emerito Franco Pedrotti,
già Consigliere del Parco e già Presidente della commissione scientifica del Parco “

da Valentina Venturi | 13 Lug, 2022 | Energia
Il gasdotto Sulmona-Foligno, parte del progetto del gasdotto Linea Adriatica, provocherà il taglio di almeno cinque milioni di alberi. La stima del numero di alberi è conservativa, in quanto non tiene conto di tutti quelli che saranno abbattuti per l’apertura delle piste forestali necessarie ai lavori. Il percorso passa attraverso molte aree protette, tra cui diversi Parchi Nazionali e Regionali, che verranno devastati dai lavori.
Il gasdotto passerà inoltre su aree ad alto rischio sismico, e incredibilmente sul tracciato non è stato fatto alcuno studio in tal senso. Si prevede di fare una valutazione sismica “in corso d’opera”: una vera follia a danno di territori che a causa dei terremoti hanno già pagato un prezzo altissimo.
Eppure i metanodotti già presenti nel nostro paese possono trasportare 100 miliardi di metri cubi all’anno, risultando quindi già sovradimensionati rispetto al bisogno nazionale. Il gasdotto, infatti, dovrebbe proseguire fino a Minerbio, nel bolognese, e da qui portare il gas in Europa Centrale, servendo quindi altri paesi europei e non l’Italia, che però pagherebbe gli elevati costi economici e ambientali. Non a caso Eni e Agigas hanno definito il progetto “anacronistico”.
In un momento storico in cui è chiara la necessità di combattere il riscaldamento climatico, e si parla continuamente di abbandono delle fonti fossili e di piantare alberi per assorbire CO2 dall’atmosfera, il Governo Italiano progetta di devastare centinaia di km di aree protette per un nuovo gasdotto. Alla luce di queste politiche, i pochi spiccioli dati alle amministrazioni locali per qualche alberatura urbana in più appaiono per ciò che sono: uno specchio per le allodole, per distrarre da politiche che abbattono milioni di alberi che abbiamo già e che non hanno bisogno di essere piantati, e che fanno parte di ecosistemi complessi da cui dipende la sopravvivenza di moltissime altre specie animali e vegetali. Sulle promesse di ridurre le emissioni, poi, stendiamo un velo pietoso.
È questa la transizione ecologica con cui è stato sostituito il Ministero dell’Ambiente? Dove sono le rinnovabili? Dov’è il risparmio energetico? Gli italiani, durante l’inverno, tengono in casa una temperatura media di circa 22 gradi: ben al di sopra dei 20 gradi massimi consigliati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il nostro patrimonio edilizio è vecchio ed energeticamente poco efficiente. C’è molto lavoro da fare, a partire dal consumo energetico di ogni singolo cittadino, ma nuovi metanodotti che distruggeranno parte dei nostri territori naturali più pregiati non sono parte della soluzione. Sono parte del problema.

da Valentina Venturi | 12 Lug, 2022 | Clima
Conferenza scientifica multidisciplinare fra ricerca e azione
“Dalla Strategia di Bioeconomia della Commissione europea alla Bioeconomia integrata e in armonia con la vita e le leggi della natura: analisi, pratiche, esperienze, attività”
12 e 13 dicembre – Roma presso la Società Geografica Italiana
Premessa
Il 25 settembre 2020 si è tenuta la conferenza multidisciplinare “La Strategia europea di Bioeconomia: scenari e impatti territoriali, opportunità e rischi” – patrocinata da società scientifiche e università – che ha raccolto i contributi di storici, geografi, economisti, urbanisti, costituzionalisti, biologi, biologi forestali e medici le cui analisi hanno messo in evidenza una serie di criticità sulla base delle quali si può asserire che la Strategia di Bioeconomia della Commissione Europea (del 2012 aggiornata nel 2018) e la conseguente Strategia Italiana siano piuttosto distanti dall’idea originaria di Bioeconomia teorizzata negli anni sessanta da Nicholas Georgescu-Roegen, ovvero una bioeconomia integrata e in armonia (embedded, direbbe Karl Polanyi) con la vita e con le leggi della natura. Detta strategia, invece, riflette un’accezione relativamente recente della parola ‘bioeconomia’, che nasce dall’industria biotech, chimica, farmaceutica, agroindustriale e dai progressi della biologia, della genetica e della tecnologia molecolari, nonché dalla domanda di biomasse per usi non alimentari. Questa accezione, attualmente dominante, si fonda su una indimostrata equivalenza tra “rinnovabilità” e“ sostenibilità”, e su una visione tecnocentrica che vede nell’high-tech enelle tecnologie a controllo centralizzato le soluzioni a ogni problema ambientale e il superamento di ogni limite allo sviluppo. I lavori della conferenza hanno messo in luce che la Strategia di Bioeconomia – promossa come la nuova frontiera dell’economia “verde” e basata sulla sostituzione delle fonti fossili con la biomassa – presenta forti contraddizioni rispetto agli stessi obiettivi che si pone, in quanto dipendente da risorse non sostenibili, non rinnovabili e dalle catene internazionali del valore, arrivando alla conclusione che, per tali ragioni, essa stessa richiederebbe una rielaborazione che non può prescindere dal suo adeguamento alla Strategia europea sulla biodiversità, nonché al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima(PNIEC).
I risultati della Conferenza sono confluiti in un Documento di Valutazione e Indirizzo, inviato alla Commissione europea, al Governo e ai parlamentari italiani e pubblicato sulla Rivista “Economia e Ambiente” (1/2021) liberamente scaricabile dall’homepage del sito www.economiaeambiente.it.
Le tematiche della conferenza sono state oggetto di ulteriore approfondimento e aggiornamento, in parte svolti nel quadro del Pra 2020 dell’Università di Foggia ‘La Bioeconomia in Europa e in Italia: politiche e territori. Scenari socio-economici, ambientali e geopolitici’ e confluiti in un volume attualmente in corso di pubblicazione con la Società dei Territorialisti Edizioni e presto disponibile in open access.I promotori della conferenza, nella convinzione che la Strategia di bioeconomia non rappresenti solo un’opportunità da cogliere “a tutti i costi”, hanno ritenuto di costituire l’Osservatorio Interdisciplinare sulla Bioeconomia (OIB) – www.osservatoriobioeconomia.it– per il monitoraggio e lo studio delle iniziative e dei progetti ispirati alle diverse accezioni di Bioeconomia, al fine di contribuire alla comprensione dei processi in corso e dei possibili scenari. La seconda fase di quest’iniziativa sulla tematica in questione prevede l’organizzazione di una conferenza multidisciplinare fra ricerca e azione incentrata sulle pratiche di bioeconomia coerenti con la concezione originaria di Georgescu-Roegen.
L’iniziativa, organizzata nell’ambito del PRA 2020 dell’Università di Foggia, è promossa dall’Osservatorio Interdisciplinare sulla Bioeconomia e dalla Rivista scientifica “Economia e Ambiente” e patrocinata dalle seguenti organizzazioni: AIIG, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia; Associazione “Dislivelli”; ISDE, International Society of Doctors for the Environment; Fondazione “Allineare Sanità e Salute”, Fondazione di partecipazione delle Buone Pratiche, SdT, Società dei territorialisti e delle territorialiste; SGI, Società Geografica Italiana; SIRF, Società Italiana di Restauro Forestale; SIU, Società Italiana degli Urbanisti, SSG, Società di Studi Geografici; Corso di Laurea in Scienze della Montagna, Università della Tuscia; Dipartimento di Architettura, Università di Firenze; Dipartimento di Economia, Management e Territorio, Università di Foggia.
Approccio scientifico alla conferenza e contenuti
Il periodo che stiamo vivendo è un periodo di crisi ecologica (con riferimento all’accezione etimologica del termine e, dunque, anche alla sua componente “sociale”), di stravolgimenti e apparenti cambiamenti sul piano politico, nonché di caos sistemico. Molte delle attuali attività e politiche economiche “verdi” – comprese quelle che si richiamano alla “bioeconomia” – sono basate sul paradigma riduzionista, meccanicista e utilitarista, sul dogma della crescita economica e della competizione, designate dalla stessa ideologia neoliberista che ha prodotto le problematiche e i guasti di cui ora le nuove politiche si propongono come “soluzione”. Insomma, tali iniziative “bio” ripropongono la stessa logica industrialista alla base dell’economia “fossile”. Pertanto, riteniamo urgente affiancare al necessario processo di interpretazione delle attuali politiche “verdi”, lo sviluppo di ricerche, studi e analisi di esperienze concrete, orientate a una bioeconomia che sia realmente integrata e in armonia con la vita e la natura, che possano costituire un punto di riferimento a livello sia teorico sia concreto per l’ormai non più procrastinabile salto di paradigma.
La bioeconomia, secondo la teoria di Nicholas Georgescu-Roegen, si fonda sul presupposto che i processi economici, investendo il mondo fisico, sono soggetti alle sue leggi, prima fra tutte l’entropia, ovvero la irreversibile dissipazione di energia e materia generata dai processi di trasformazione. I processi di produzione sono visti come un insieme di fondi (terra, capitale e lavoro) e flussi (risorse naturali, prodotti e scarti), in cui non vi è sostituibilità tra fondi e flussi: si può sostituire il lavoro con il capitale, ma certamente non le risorse con il capitale. D’altro canto, l’efficienza energetica, lungi dal potersi riferire solo al mero rapporto tra input e output di energia, deve considerare i processi dissipativi della materia coinvolti nella trasformazione dell’energia stessa. Un’economia sostenibile e circolare non richiede, dunque, soltanto flussi rinnovabili, ma anche una relazione fondi-flussi che rispetti e mantenga l’identità dei fondi, ovvero una compatibilità fondativa tra la velocità/densità dei flussi nella tecno-sfera e la capacità/velocità di rigenerazione dei fondi della biosfera.
Partendo dall’assunto che le civilizzazioni umane hanno prodotto nel tempo territori e paesaggi con sapienza e saggezza mantenendo una relazione fondi-flussi equilibrata, possiamo affermare che proprio la modalità e la capacità di tessere tale relazione in base a valori e interpretazioni diverse ma sempre armoniche con la natura ha portato alla grande differenziazione locale delle forme dei nostri contesti di vita. Oggi come un tempo sono proprio le pratiche sociali che consentono di entrare nella modalità complessa e integrata di economie capaci di interagire con i beni naturali e di riprodurre territori, paesaggi, risorse.
La conferenza si interroga su come attuare nella contemporaneità una bioeconomia integrata e in armonia con la vita e la natura. Sarà possibile presentare contributi basati su riflessioni, studi e pratiche che trattano di esperienze concrete coerenti con principi quali:
- la visione sistemica dell’ambiente;
- l’ambiente come fondamento del palinsesto territoriale e paesaggistico;
- l’assunzione del concetto di limite ecosistemico come regolatore delle attività economiche;
- l’adattamento del metabolismo industriale ai cicli naturali;
- il concetto di sostenibilità fondato sulla capacità di rigenerazione delle risorse naturali e sulla necessità di preservazione dell’equilibrio del ciclo biogeochimico;
- la governance politica e il progetto territoriale e paesaggistico basati sulla pianificazione ecologica partecipata e sulla salvaguardia delle matrici vitali partendo in primis dell’insediamento;
- l’uso delle risorse fondato sulla riduzione dei consumi di materia ed energia;
- la promozione dell’innovazione sociale, ovvero della valorizzazione delle conoscenze e dei saperi della natura, integrate ai contesti di vita;
- l’agroecologia e, più in generale, i modelli virtuosi di agricoltura in grado di rigenerare l’ambiente e il territorio;
- i modelli locali di produzione basati sulla diversità, sulla resilienza, sui beni relazionali e sulla partecipazione.
La conferenza si compone di tre sezioni: una sessione sui paradigmi scientifici alla base degli approcci bioeconomici nella quale saranno presentati i risultati del PRA 2020 dell’Università di Foggia insieme ad alcuni contributi dei fondatori dell’Osservatorio Interdisciplinare sulla Bioeconomia (OIB); e due sessioni aperte a contributi esterni suddivise nelle seguenti tipologie:
- riflessioni teoriche o casi studio che raccoglierà i contributi di studiosi che si occupano di bioeconomia coerente con la teoria di Georgescu-Roegen, ovvero l’economia integrata e in armonia con la natura e la vita
- sulle pratiche nella quale saranno accolte esperienze e pratiche coerenti con i principi enunciati in precedenza con l’obiettivo, fra gli altri, di conferire rilevanza scientifica alle pratiche sociali per farle entrare nel dibattito scientifico ed accademico.
I temi che la conferenza intende indagare in maniera preminente fanno riferimento ai seguenti campi:
- agricoltura, allevamento, pesca
- acqua e foreste
- produzione manifatturiera
- energia
- servizi
- gestione delle risorse come beni comuni
- insediamenti
- paesaggio
- salute.
Modalità di presentazione dei contributi e tempi di consegna
L’approvazione del contributo prevede in via preliminare l’invio di una sintesi (abstract) contenente:
- titolo
- testo (massimo 2.000 caratteri spazi inclusi)
- 3 parole chiave.
A seguire:
- nome/i dell’autore/i
- ente di afferenza o organizzazione di appartenenza
- dichiarazione di possibili conflitti di interesse
- indicazione del campo tematico
- indicazione della modalità di presentazione del lavoro.
La sintesi (abstract) dovrà essere inviata entro il 30 giugno a
conferenza.2022@osservatoriobioeconomia.it
L’approvazione avverrà entro il 30 settembre sulla base dei seguenti criteri:
- pertinenza al tema oggetto della conferenza,
- coerenza del caso di studio o della pratica con i principi enunciati di una bioeconomia integrata con la vita e e le leggi della natura. Non saranno ammesse le proposte di contributo che presenteranno casi di studio o esperienze riconducibili alla bio-industria, ovvero che fanno riferimento a una mera sostituzione delle risorse fossili con quelle organiche.
Il lavoro finale dovrà essere inviato entro il 31 gennaio2023 ai fini della pubblicazione.
Modalità di presentazione dei lavori:
- riflessione teorica e casi studio con indicazione della preferenza di: presentazione orale (15 minuti), comunicazione orale breve (7 minuti), poster;
- pratiche con indicazione della preferenza di presentazione orale (15 minuti), comunicazione orale breve (7 min.), poster (in formato pdf), video (mp4, durata massima 3 min.)
In base ai materiali presentati, gli organizzatori della conferenza potranno richiedere una modalità specifica di presentazione, che verrà comunicata al momento dell’accettazione della sintesi (abstract).
ATTENZIONE: ogni partecipante alla conferenza può presentare un solo contributo come primo autore, pur potendo partecipare come co-autore in altri contributi.
Per qualsiasi ulteriore informazione: conferenza.2022@osservatoriobioeconomia.it
Link PDF della Call: https://www.osservatoriobioeconomia.it/wpcontent/uploads/2022/05/call_II_conferenza_bioeconomia_2022.pdf

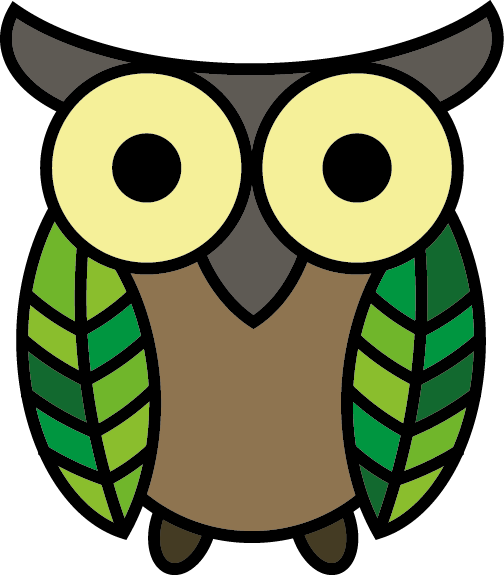




Commenti recenti