
da Valentina Venturi | 10 Nov, 2023 | Difesa Foreste
Il Gruppo Unitario per le Foreste Italiane prende atto delle gravi parole del Sindaco di Altavilla Silentina apparse in virgolettato sul Corriere di Mezzogiorno del 9 Novembre. Non corrisponde al vero che l’intenzione del Comune sia quella di diradare il bosco Chianca: il bosco infatti sta venendo tagliato a raso. Non è vero che le ragioni per cui il bosco sta venendo tagliato siano inerenti al suo stato fitosanitario, per la presenza di piante “marce” (sic!). Il Sindaco tenta di strumentalizzare la risposta della Regione Campania a questo Gruppo, che concerne solamente aspetti interpretativi della normativa, e che anzi ribadisce la possibilità che il bosco possa essere tagliato a raso, come previsto dal piano di assestamento, che tuttavia è ormai scaduto. A tale lettera della Regione abbiamo prontamente risposto, confutando nel merito le ragioni di diritto ivi esposte, ritenendole gravemente inesatte. Sottolineiamo inoltre che il taglio del bosco ha già prodotto rapporti giuridici di natura economica tra il Comune, il tecnico pagato 16 mila euro, e la ditta boschiva che ha sborsato 200 mila euro non certo per eseguire tagli fitosanitari.
I tagli per ragioni sanitarie e i diradamenti, infatti, hanno una procedura di legge completamente diversa dalle comunicazioni formali inoltrate dal Comune alla Regione, che in questo caso concernono esclusivamente il taglio del bosco a fini economici. In nessun caso, nella missiva della Regione, si fa riferimento a diradamenti, né a problemi fitosanitari, quindi è totalmente fuorviante lasciar credere che le ragioni del taglio siano quelle addotte dal Sindaco.
Questo Gruppo ha piuttosto sostenuto sin dall’inizio come il bosco di Chianca, utilizzato a ceduo fino a 45 anni fa, sia adesso divenuto strutturalmente una fustaia, anche da un punto di vista legislativo, e che l’unico intervento ammissibile sia, appunto, l’intervento di diradamento che il Sindaco usa a sproposito, aggravando le sue dichiarazioni con riferimenti alla possibilità che il bosco, se non tagliato, muoia. Questa tesi è ampiamente smentita dalla scienza. Le foreste esistono sul pianeta da circa 350 milioni di anni, mentre l’essere umano ha fatto la sua comparsa circa 400mila anni fa. Prima dell’arrivo della nostra specie, le foreste coprivano gran parte delle terre emerse, e per merito delle nostre azioni si sono drasticamente ridotte. È quindi lapalissiano che il bosco non ha alcun bisogno dell’uomo e delle sue motoseghe per sopravvivere e prosperare, ma migliora invece in struttura e complessità quando l’uomo smette di tagliare gli alberi e lo lascia alle sue dinamiche evolutive naturali.
Esprimiamo inoltre il nostro sconcerto per quanto detto sulla fauna selvatica: secondo quanto riferito dai cittadini presenti all’assemblea di ieri sera, la giunta avrebbe, incredibilmente, sostenuto che “nel bosco non ci sono animali”. Affermazione assolutamente assurda per qualsiasi ambiente naturale, ma resa ancora più comica dalla vicinanza dell’area al Parco Nazionale del Cilento.
Riteniamo che il rapporto di fiducia tra il Sindaco e i suoi cittadini si sia irreparabilmente rotto, e invitiamo pertanto il primo cittadino di Altavilla Silentina a chiedere scusa alla cittadinanza e a rimettere il suo mandato.
Noi, nel frattempo, continueremo ad informare l’opinione pubblica, i cittadini di Altavilla Silentina e gli organi di controllo circa questa vicenda sempre meno chiara, mossi esclusivamente dalla necessità di salvaguardare il patrimonio boschivo, soprattutto in questo periodo storico di crisi climatica in cui gli ecosistemi forestali sono i nostri più importanti alleati.

da Valentina Venturi | 23 Ott, 2023 | Difesa Foreste, Foreste
Oggi il GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane festeggia il compleanno del nostro Fabio Clauser, decano dei Forestali italiani, che compie 104 anni. Nato a Malosco (TN) nel 1919, ha ricoperto diversi incarichi: Direttore del Parco Nazionale dello Stelvio, Capo dell’Ufficio Assestamento Forestale dell’Azienda di Stato Italiana per le Foreste demaniali (ASFD), Amministratore delle Foreste Casentinesi, Amministratore della Foresta di Vallombrosa, Vice Direttore del Corpo Forestale dello Stato (CFS), e Vice Direttore della Direzione generale per l’Economia montana e le foreste dello Stato Italiano. Suo il merito di aver istituito la prima riserva integrale in Italia, quella di Sasso Fratino, nel 1959.
A 104 anni, Clauser continua a lottare per difendere le foreste italiane. È costretto a farlo da quella che non ha esitato a chiamare “una rapina nei confronti delle future generazioni”, una politica forestale nazionale che ha dimenticato le lezioni del passato, quando il Corpo Forestale dello Stato operava massicci rimboschimenti contro il dissesto idrogeologico, quando i parchi nazionali venivano allargati e non ristretti, quando il prelievo di legname dal bosco era davvero sostenibile.
Clauser da sempre si batte contro il governo a ceduo dei boschi, una forma di gestione del patrimonio boschivo figlia di un’economia povera, improntata sulla produzione di legna da ardere anziché di legname da opera per utilizzi nobili del legno come la falegnameria e la bioedilizia.
Per avere legname di qualità e non doverlo importare dall’estero, infatti, è necessario avere boschi maturi, con alberi di grandi dimensioni e un’alta provvigione per ettaro. Dopo aver raggiunto il minimo storico nel secondo dopoguerra, le foreste italiane erano in ripresa per merito di persone come Fabio Clauser.
Ma ora tutto questo lavoro è messo a rischio dall’aumento dei tagli boschivi, causati dai generosi incentivi pubblici alle biomasse forestali per la produzione di energia elettrica. Una forma di energia definita rinnovabile che tale non è: come ha più volte ribadito lo stesso Clauser, per riassorbire la CO2 emessa dalla combustione del legname, una foresta impiega molti decenni. Un tempo che non abbiamo in quest’epoca di crisi climatica. A questo si aggiunge la distruzione di ecosistemi preziosi per molte specie a rischio estinzione.
Il GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane si batte contro questo dissennato iper-sfruttamento del patrimonio boschivo italiano, chiedendo la chiusura delle centrali a biomasse forestali, una transizione energetica davvero ecologica, e la forte limitazione della gestione a ceduo, per lasciare alle future generazioni foreste che possano al contempo fornire i benefici ecosistemici che possono dare solo le foreste mature, e un legname di qualità per le nostre eccellenze industriali, con un prelievo davvero sostenibile. In tutti questi anni, Fabio Clauser ci ha onorato del suo convinto appoggio e sostegno, di cui non lo ringrazieremo mai abbastanza.
Cogliamo l’occasione del compleanno di questo gigante per lanciare un appello al mondo forestale italiano: ascoltate la saggezza di chi si è occupato delle nostre foreste per quasi un secolo, fermate le motoseghe, e proteggete cioè che avete ereditato da persone come Clauser, e che gestite solo sotto forma di prestito dai vostri figli.

da Valentina Venturi | 29 Set, 2023 | Foreste
29 settembre 2023 – È stato approvato, in sede di conversione del Decreto legge “Asset” che trattava di tutt’altra materia, un emendamento presentato da FdI che cancella totalmente la tutela paesaggistica dei boschi nei confronti dei tagli boschivi, manomettendo il Codice Urbani e il senso originario della legge Galasso: la tutela dei boschi nelle aree vincolate con decreto ed il concetto di taglio colturale.
La difesa dei boschi ha subito, negli anni, vari attacchi del mondo forestale, sia da parte delle ditte, che dei politici degli enti locali, che di alcune rappresentanze dei dottori agronomi e forestali, che di una frazione del settore accademico, contro il parere prevalente di biologi, botanici e studiosi dell’ecologia e del paesaggio.
Le regioni, in modo incontrollato, hanno esteso il concetto di taglio colturale ad ogni possibile ed immaginabile trattamento selvicolturale, anche il taglio a raso, che si applica ai nostri boschi ceduo. Il motivo questa volta è chiaro, come dice letteralmente l’art. 5–bis del decreto, senza tanti giri di parole: incentivare la filiera del legno, aumentare la concorrenza sui mercati esteri (specialmente quelli balcanici e nord europei, che tagliano boschi a raso su grandi superfici) e accrescere l’approvvigionamento interno di legno, rallentando l’evoluzione degli ecosistemi forestali. Si annulla quindi la tutela paesaggistica, di rango costituzionale primario, al fine di incrementare l’economia. Del resto, non è la prima volta che principi costituzionali vengono violati pur di aumentare i tagli boschivi: pensiamo per esempio al Testo Unico per le Filiere Forestali, che consente alle Regioni di obbligare i proprietari a tagliare i loro boschi.
Questo la dice lunga non solo sull’attuale politica di tutela ambientale e dei beni culturali, ma sulla stessa cultura costituzionale, tra l’altro recentemente arricchita dalla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della biodiversità, gravemente fraintesa da chi ha proposto e votato questo articolo. Una scelta del tutto anticostituzionale.
Questa non vuole essere una critica politica all’attuale maggioranza, visto che tale volontà politica, che covava dal 2018, anno di approvazione del controverso Testo Unico Forestale, è trasversale ai maggiori partiti, con asse privilegiato PD-Lega, cui si è aggiunta anche FdI.
Dietro questa decisione ci sono molte lacune culturali, scientifiche e concettuali da parte dei proponenti, nonché palesi ragionamenti illogici e aberranti tra i sostenitori, la cui applicazione apre allo smantellamento di ogni tutela ambientale e paesaggistica.
Innanzi tutto da parte di coloro che sostengono che l’opera dell’uomo ha formato il paesaggio, e quindi anche i tagli, in quanto opera dell’uomo, fanno parte del paesaggio. Con questo ragionamento, potremmo sostenere che anche le case e i palazzi fanno parte delle opere umane, e quindi costruire qualsiasi casa o palazzo non danneggi mai il paesaggio.
Chi sostiene poi che l’autorizzazione paesaggistica danneggi l’economia forestale in quanto inutile orpello burocratico, ammette di conseguenza, con tale ragionamento, che anche l’autorizzazione paesaggistica per costruzioni, apertura di cave, e ogni altra opera, essendo oggettivamente un orpello alle attività produttive, potrà essere superata a richiesta degli operatori e dei professionisti del settore (imprese edili, ingegneri, architetti, che invece non si sognano nemmeno lontanamente di farlo).
Il prossimo passo sarà quindi, conseguentemente e coerentemente, l’abrogazione dell’art. 9 della Costituzione?
Adesso finalmente parte del settore dei tagliatori e dei dottori forestali avrà mani libere sui boschi che, coi loro 11 milioni di ettari, rappresentano il più vasto patrimonio culturale della nazione.
Con il presente comunicato lanciamo pertanto l’appello a tutte le associazioni di protezione ambientale, ai comitati, ai gruppi di azione civica e ai cittadini, affinché la protesta della società civile si elevi sopra questa barbarie.

da Valentina Venturi | 4 Set, 2023 | Animali, Biodiversità, Difesa Foreste
L’uccisione dell’orsa Amarena deve imporre una riflessione sulla gestione degli orsi marsicani e su come tenerli lontani dai paesi, in particolare su come far trovare loro cibo a sufficienza nelle aree non occupate dall’uomo. Un elemento troppo spesso trascurato in questo senso è la qualità e il grado di complessità dei boschi che sono territorio dell’orso, la loro importanza nel fornire fonti alimentari a questa specie, e l’impatto che hanno i tagli boschivi nel compromettere la capacità delle foreste di produrre cibo per gli orsi.
L’orso è un animale onnivoro e una parte rilevante della sua alimentazione è costituita da ghiande (prodotte dalle querce) e di faggiole (il frutto del faggio): sono stati trovati escrementi di orso composti unicamente da ghiande e faggiole. Ma non tutti gli alberi producono ghiande e faggiole allo stesso modo. Esattamente come un bambino ha bisogno di crescere prima di entrare nell’età riproduttiva, anche le piante non fruttificano durante i primi anni di vita.
Un faggio comincia a fruttificare non prima dei 20-30 anni di età, mentre le querce cominciano a fruttificare a 30-40 (le farnie un po’ prima delle altre specie). Un albero troppo giovane, quindi, non produce frutti, e non fornisce cibo agli animali selvatici. Molti boschi sono in questa situazione, in particolare quelli nati dall’espansione del bosco in zone prima coltivate.
Ci sono poi i boschi governati a ceduo, dove le piante vengono tagliate alla base per fare legna, e ricrescono con giovani rami chiamati polloni. Questa forma di governo del bosco, dannosa perché lascia il suolo forestale quasi completamente scoperto, è molto diffusa in Italia e purtroppo viene utilizzata anche all’interno dei parchi nazionali.
Le piante ceduate devono ricrescere da capo dopo ogni taglio, ricostituendo la parte aerea. L’albero quindi spende moltissime energie per sopravvivere al taglio, e non fruttifica per qualche anno, o lo fa ma producendo pochissimi frutti. Una pianta ricresciuta dopo un taglio ceduo è un pianta piccola, e dopo turni molto brevi (di solito 20 anni, ma a volte anche meno) viene tagliata di nuovo. Questi alberi, condannati a non poter mai raggiungere dimensioni dignitose, hanno una produzione di frutti misera e assolutamente imparagonabile a una pianta secolare.
Altro effetto delle continue ceduazioni è il taglio del sottobosco, che fornisce cibo agli animali selvatici sotto forma di frutti di bosco, insetti e micromammiferi. Il sottobosco viene eliminato per consentire il passaggio dei macchinari per il taglio boschivo.
È quindi importante, nel considerare l’areale dell’orso, non concentrarsi solo sulla sua estensione, ma anche sulla qualità e complessità dei boschi compresi nel territorio della specie. Boschi più evoluti hanno una capacità portante per la specie molto superiore a boschi giovani o ceduati, che sono ecosistemi immaturi dove non ci sono catene alimentari stabili e articolate. Gli orsi marsicani hanno bisogno di un numero rilevante di aree boschive lasciate all’evoluzione naturale, con boschi indisturbati da tagli, e ricchi di cibo per loro e altre specie animali, se vogliamo tenerli lontani dai centri abitati per favorire la convivenza e salvare la specie.
Nei boschi sottoposti invece a gestione, bisogna abbandonare il governo a ceduo e puntare su quello ad alto fusto, più rispettoso delle dinamiche naturali. Si possono fare tagli oculati e limitati, senza aprire o destrutturare troppo la foresta, praticando una selvicoltura più ecosostenibile e meno impattante, che lasci un numero adeguato di piante mature che possono fruttificare e nutrire la fauna.
Anche le pinete artificiali, di cui si invoca così spesso il diradamento, possono fornire cibo agli orsi marsicani. A causa della grande quantità di legno morto al loro interno sono ricche di insetti e micromammiferi: tutti cibi apprezzati dagli orsi.
Tutto questo non esclude altri possibili interventi per l’alimentazione degli orsi, come una possibile ripresa della pasturazione in aree isolate. Ma un discorso sulle fonti alimentari degli orsi non può prescindere da una discussione sullo stato delle foreste.
È utile in questo senso anche la conservazione degli esemplari di alberi da frutto rimasti nei terreni non più coltivati. Questi alberi camporili possono essere di varie specie e trovarsi in condizioni diverse: in pieno campo, ai margini meno coltivabili o sui confini, come accade nei pascoli e seminativi arborati o cespugliati, per le querce camporili, o per gli alberi maritati alle viti (aceri e olmi campestri, ma anche gelsi e più raramente meli e altre specie di alberi). Sono piante robuste, longeve e rustiche, selezionate dalla natura, che possono costituire una risorsa trofica per la fauna.
Le foreste possono anche essere arricchite di fonti alimentari per l’orso con la messa a dimora di alberi da frutti come meli e peri selvatici. Queste piante sono perfette ai margini di boschi e praterie, o dove c’è una gestione orientata alla conservazione di pascoli, creando pascoli arborati, o garrighe, e andando a creare corridoi ecologici ricchi di fonti alimentari.
Le garrighe, aree aperte e aride dove il bosco non arriva, e i pascoli arborati possono essere di particolare interesse a questo scopo. La messa a dimora di alcuni alberi da frutto in questi contesti permetterebbe anche di ricreare alcuni elementi tradizionali del paesaggio, con interventi che aumentino la diversità a mosaico degli habitat secondari. I pascoli arborati, per esempio, consentono un uso sinergico del territorio. Questi luoghi possono agire come zone buffer per tenere lontani i selvatici dalle attività agricole e dai paesi. Alberi e arbusti di questo tipo possono essere una risorsa d’emergenza per le specie più minacciate, specialmente negli anni non di pasciona.
Altra azione importante può essere il restauro dei ramneti in alta quota, dove sono primari.
Ogni specie vivente, compresa quella umana, è legata a doppio filo al proprio ambiente naturale. Le azioni per salvare le specie a rischio estinzione devono quindi avere come punto di partenza la conservazione del suo habitat. Se vogliamo salvare gli orsi marsicani, dobbiamo avere più cura delle loro foreste.

da Valentina Venturi | 16 Ago, 2023 | Difesa Foreste, Foreste, Piano AIB
Pubblichiamo di seguito la lettera ricevuta dal Professor Franco Pedrotti, luminare della botanica:
“L’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise ha preso la decisione di effettuare un
taglio di pini nella pineta di Villetta Barrea.
Viene subito da dire che un parco nazionale ha per scopo quello di proteggere gli alberi e non di
tagliarli. La pineta di Villetta Barrea è un bosco residuo e relitto, di grande interesse fitogeografico,
poiché rappresenta l’ultimo frammento di una pineta che in passato era molto diffusa in tutto
l’Appennino centrale, come risulta dalle analisi polliniche eseguite.
In un Parco Nazionale si dovrebbero sempre prevedere alcune aree ove il bosco è lasciato al suo
libero sviluppo, in modo da raggiungere la fase ecologica della fluttuazione. In questo caso gli
alberi completano nello stesso punto il loro ciclo vitale, dal seme alla vetustà. Questa forma di
gestione dovrebbe essere applicata anche alla pineta di Villetta Barrea.
Si può anche pensare a una forma di gestione più articolata della pineta, sempre che non comporti
l’eliminazione di porzioni della stessa. In nessun caso è ammissibile il taglio, né lo sfoltimento
giustificato da prevenzione incendio.
La prevenzione incendio va fatta utilizzando uomini e mezzi adeguati che non prevedano la
distruzione o la manomissione del bosco, altrimenti distruggiamo ciò che invece vorremmo tutelare.
Si chiede pertanto che il Parco voglia ripensare e sospendere definitivamente questa insensata
decisione, ancor più che questa pineta rappresenta un alto valore ecologico, storico, culturale e botanico.
Essa mostra una importante rinnovazione di pino e latifoglie, nonché una struttura forestale ormai
notevole. Questa pineta è importante anche per la stabilità idrogeologica e per la biodiversità,
racchiudendo specie di piante non comuni (es.: Orthilia secunda).
Essa incarna anche un alto valore da un punto di vista forestale, in quanto essa rappresenta l’opera
dei forestali e la pineta madre dei rimboschimenti realizzati in Italia centrale.
Professore Emerito Franco Pedrotti,
già Consigliere del Parco e già Presidente della commissione scientifica del Parco “

da Valentina Venturi | 3 Ago, 2023 | Biomasse, Energia, Foreste, Uncategorized
L’associazione GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane applaude la decisione della Giunta Regionale della Calabria e del suo Presidente, Roberto Occhiuto, che ha approvato il Piano del Parco Nazionale del Pollino senza concedere deroghe alla potenza della centrale del Mercure, grande impianto che produce energia elettrica bruciando biomasse forestali.
Il Piano del Parco prevede la presenza di centrali a biomasse fino alla potenza di massima di circa 2,7 MWe, escludendo quindi la megacentrale che ha una potenza circa 15 volte superiore.
“Il Pollino, perciò, non ospiterà più megacentrali a biomasse, pericolose per la salute dei cittadini e per l’ambiente, ma anche per lo sviluppo turistico ed economico dell’area protetta più grande d’Italia, che è anche tutelata dall’UE in quanto ZPS, nonché patrimonio UNESCO, e che dunque non può inseguire una impossibile e perniciosa pseudo-industrializzazione, utile soltanto alla proprietà della centrale e dannosa, sotto ogni aspetto per le popolazioni residenti che tante volte ed in maniera partecipatissima si sono mobilitate contro la centrale”, dice Ferdinando Laghi, consigliere regionale e membro delle associazioni ISDE e GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane-, che combatte contro la centrale da oltre 20 anni, a difesa delle foreste italiane e della salute dei cittadini calabresi e lucani.
La megacentrale collocata nel Parco Nazionale del Pollino brucia circa 350.000 tonnellate di legno vergine all’anno (frutto del taglio di centinaia di migliaia di alberi) per produrre energia elettrica: una modalità di produzione di energia – in una regione che produce circa tre volte l’energia di cui necessita e a cui la centrale del Mercure contribuisce per appena lo 0,0002 % — che l’Italia deve abbandonare per tre importanti ragioni.
In primis, bruciare biomasse forestali accelera il riscaldamento globale: le energie da biomasse legnose sono più climalteranti persino delle energie fossili poiché, a parità di energia prodotta, emettono il 150% di CO2 rispetto al carbone e il 300% rispetto al gas naturale (da “Letter From Scientists To The EU Parliament Regarding Forest Biomass” del gennaio 2018), mentre il riassorbimento di equivalenti quantità di CO2 da parte di nuovi alberi richiederà molti decenni: un tempo che non abbiamo a disposizione. Il taglio di un numero così elevato di alberi va ad aggravare il riscaldamento globale di cui una delle concause principali è proprio la deforestazione. Per rimuovere la CO2 accumulata abbiamo bisogno di grandi alberi e delle foreste vergini, che la assorbono oltre 50 volte in più rispetto ai nuovi alberi e alle piantagioni.
Secondo, la combustione di biomasse forestali presenta un grave rischio per la salute dei cittadini, in particolare in una zona come la Valle del Mercure, dove i fumi di combustione ristagnano a lungo a causa del fenomeno dell’inversione termica. La combustione di tutte le biomasse legnose, secondo i dati ufficiali dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) e di ISPRA, per la sola emissione in atmosfera di PM2,5, causa in Italia circa 20.000 morti premature ogni anno, senza contare le patologie dovute alle emissioni di inquinanti emessi nella combustione del legno (arsenico, mercurio, diossina, furani, IPA…). L’Italia detiene il triste record in Europa per morti premature derivanti dalla cattiva qualità dell’aria.
Terzo, l’utilizzo delle biomasse legnose come fonte di energia minaccia le foreste. Il patrimonio boschivo italiano èormai sfruttato intensivamente e oltre i limiti di rigenerazione dello stesso. Un disastro ecologico che compromette gravemente gli ecosistemi forestali, privando le specie animali e vegetali del loro habitat, e che ha effetti anche sulla popolazione, in quanto la conservazione del patrimonio forestale è essenziale per la stabilità del suolo e la regimazione delle acque.
La produzione di energia da combustione di biomasse legnose non può quindi essere considerata energia pulita, non dovrebbe poter usufruire di generosi incentivi economici, e andrebbe abbandonata al più presto per la salute del pianeta, dei cittadini e per la nostra sicurezza sanitaria e sociale. GUFI è per un utilizzo razionale e sostenibile del legno, ottenuto da selvicoltura ecologica e in boschi destinati all’uopo, e per qualsiasi prodotto in cui il carbonio in esso contenuto resti allo stato solido.
Foto: Di Demincob – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31953639

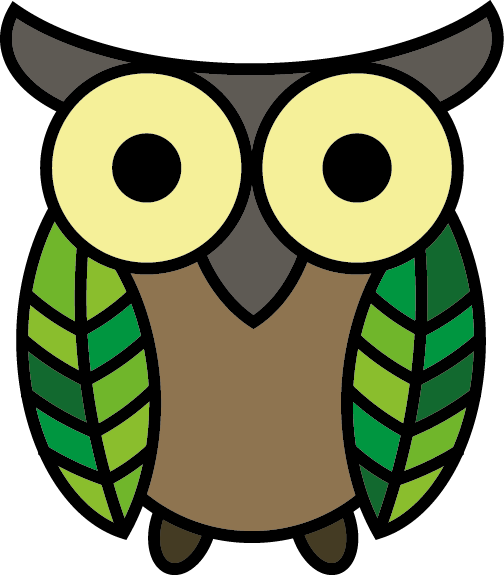





Commenti recenti