
da Valentina Venturi | 1 Giu, 2020 | Animali, Clima, Foreste
La Regione Piemonte ha posticipato la data di termine del taglio ai boschi di latifoglie, permettendo di tagliare a primavera ormai arrivata con gravi danni all’ecosistema. Protestano le associazioni.
Torino, 21 aprile 2020 – Le associazioni GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane e ISDE Italia – Medici per l’Ambiente protestano per la proroga del periodo di taglio delle latifoglie concessa dalla Regione Piemonte, che permette di proseguire il taglio dei boschi a ceduo nonostante la primavera sia ormai arrivata e sia incominciato il periodo vegetativo degli alberi e di nidificazione dell’avifauna. Una scelta politica che, per venire incontro alle richieste delle ditte di taglio boschivo, ignora i tempi dettati dalla Natura e la necessità di lasciare indisturbate le nostre foreste (già sfruttate in modo intensivo e insostenibile durante il resto dell’anno) nel periodo cui gli alberi riprendono la crescita e gli animali si riproducono.
I boschi di latifoglie governati a ceduo sono sottoposti a un tipo di taglio che consiste nel rimuovere il tronco dell’albero lasciando solo una ceppaia da cui nasceranno nuovi polloni: un sistema che sfrutta la capacità dell’albero di ricominciare a crescere anche dopo un evento traumatico. Affinché la pianta possa riprendersi dopo il taglio però sono necessarie alcune condizioni, e per questo motivo le norme forestali dettano in modo rigoroso i modi ed i tempi dell’utilizzazione del bosco governato a ceduo, stabilendo date differenti per i periodi di taglio a seconda dell’altitudine proprio per evitare che vengano tagliate piante già entrate nel periodo vegetativo.
Il taglio del ceduo è indicato quindi soltanto durante la stagione silvana, ovvero il periodo dell’anno in cui gli alberi non hanno le foglie e sono nella fase di riposo: in quel momento gran parte delle riserve nutritive della pianta si trova ancora allocata nell’apparato radicale. Alla ripresa del periodo vegetativo, cioè quando all’arrivo della primavera l’albero ricomincia a mettere le foglie, le sostanze nutritive traslocano dalle radici alla parte aerea della pianta. Tagliare quando questo processo è già iniziato ha diverse e gravi ripercussioni sull’albero, in quanto causa uno squilibro energetico e un forte impoverimento del vigore vegetativo della pianta; provoca l’emissione di un maggior numero di polloni avventizi, che sono meno stabili meccanicamente e meno vitali fisiologicamente; e favorisce le patologie che possono attaccare la pianta, perché le ferite sulle ceppaie si ricoprono di uno strato di linfa zuccherina, ideale per la germinazione delle spore fungine. A queste problematiche se ne aggiungono altre collaterali che coinvolgono il bosco nel suo insieme, causate dalle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco. Aumentano i rischi di danni alla corteccia e di altre lesioni al tronco anche negli alberi non tagliati, a causa delle sollecitazioni meccaniche; si interferisce pesantemente con il periodo di riproduzione di molte specie animali, che sempre più spesso avviene in anticipo a causa del cambiamento climatico; gli animali che vanno in letargo sottoterra sono già usciti e facilmente verranno uccisi durante le operazioni.
A causa del riscaldamento climatico si assiste sempre più spesso a un arrivo anticipato della stagione primaverile, con conseguente anticipo dell’entrata in vegetazione delle piante forestali e della ripresa di tutte le attività naturali dell’ecosistema forestale. Il fenomeno è stato particolarmente evidente questo inverno, che è stato il più caldo mai registrato, e con il passare degli anni il tema diventerà sempre più attuale e pressante.
Le associazioni invitano quindi la Regione Piemonte a rispettare i tempi dettati dalla natura, e a proteggere adeguatamente il patrimonio boschivo chiudendo la stagione di taglio prima dell’arrivo della primavera.

da Valentina Venturi | 1 Giu, 2020 | Animali, Difesa Foreste, Foreste
Trento, 14 maggio 2020 – Il GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane chiede che venga immediatamente fermata la realizzazione di una strada a elevatissima incompatibilità ambientale e paesaggistica nel Parco di Paneveggio, per scongiurare uno sfregio severo e persistente alla natura in un’area protetta, habitat del Gallo Cedrone.
Nel Parco Naturale di Paneveggio, in provincia di Trento, in piena area protetta, in zona classificata sia come ZSC (Zona Speciale di Conservazione) sia come ZPS (Zona di Protezione Speciale ai sensi della direttiva europea “Habitat” e ricadente per intero nella disciplina dei vincoli europei della rete Natura 2000) è in via di realizzazione una strada forestale camionabile che, se continuata, devasterà un ambiente forestale di pregio sopravvissuto alla tempesta Vaia, e porterà degrado e disturbo permanente in uno degli ultimi habitat in cui sopravvive il Gallo cedrone (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758), specie di tetraonide pregiata e protetta. L’Associazione scientifica GUFI tiene a ricordare che il gallo cedrone è anche un indicatore biologico per eccellenza, perché con la sua presenza testimonia le buone condizioni ecologiche del soprassuolo forestale del piano montano superiore e di quello sub-alpino inferiore delle Alpi. È altresì una cosiddetta “specie ombrello” in quanto la sua esistenza è legata alla possibilità di disporre di vaste superfici indisturbate e non frammentate, necessarie per la propria autoecologia.
È inoltre specie emblema e simbolo del Parco, ma dal momento che è in costante e preoccupante diminuzione nel lungo termine è considerata “vulnerabile” (VU, in quanto ad alto rischio di estinzione in natura nel prossimo futuro), secondo la Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia (2012) e secondo quella trentina (Pedrini et al., 2005). Per questo motivo il gallo cedrone ha varie disposizioni di tutela giuridica: è inserito nell’allegato III della Convenzione di Berna; è inserito negli Allegati I e II della Direttiva Uccelli (2009/147/CE), che lo elenca tra le specie per la cui protezione sono previste misure speciali di conservazione degli habitat in cui vive; a livello nazionale è protetto dalla Legge 157/92, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, che ne esclude la caccia; a livello trentino è specie protetta dalla Legge provinciale 24/1991, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”, che pone il gallo cedrone tra le specie non cacciabili.
La strada camionabile di cui è appena iniziata la costruzione dovrebbe dispiegarsi per circa quattro chilometri abbattendo alberi della foresta tra Fiera e San Martino di Castrozza, e dovrebbe unire Malga Crel, a quota 1577 metri, alla Malga Scanaiol a quota 1745 metri. Il tracciato in cui è previsto il disboscamento per far posto all’arteria stradale costituisce attualmente, per il disturbo antropico ridottissimo, un habitat residuo ideale per il gallo cedrone, che ha reso questo luogo prezioso una straordinaria arena di canto con oltre dieci galli a 1700 metri di quota. I posti con tali caratteristiche sono ormai molto rari sulle Alpi Orientali, e la frammentazione che verrebbe apportata dalla strada e il disturbo conseguente e reiterato nel tempo causato dal traffico anche turistico, oltre a danneggiare severamente la foresta, sarebbe fatale per la colonia di Gallo cedrone.
Si andrebbe, inoltre, a portare degrado ed artificializzazione in un angolo di foresta sopravvissuto alla violenza della tempesta Vaia, come se il Trentino avesse bisogno di ulteriori sciagure ambientali.
Il Parco di Paneveggio Pale di San Martino include al suo interno una porzione consistente delle aree che costituiscono il territorio delle Dolomiti Patrimonio Unesco, e Il Parco naturale di Paneveggio è socio Sostenitore della Fondazione Dolomiti UNESCO, il soggetto che ha la responsabilità della gestione del Patrimonio e l’obbiettivo di promuoverne la conoscenza e la valorizzazione.
Anche dal punto squisitamente culturale, la qualifica di Patrimonio UNESCO richiama il collegamento con Cremona, insignita di analoga attribuzione in quanto storicamente patria della liuteria di assoluta eccellenza a livello mondiale. Questa infatti è basata sull’impiego del legno di Paneveggio Pale di San Martino e tali riconoscimenti rappresentano per l’Italia, nella sua collocazione mondiale, un connubio virtuoso e nobile nella pratica e nell’immaginario, tra patrimonio naturale e patrimonio artistico-storico-culturale.
Per autorizzare un progetto simile, in passato bocciato fermamente dal Parco, è accaduto che l’Ufficio Distrettuale Forestale del Primiero, in sede di revisione del piano di assestamento forestale aziendale dell’ex Comune di Fiera di Primiero per il periodo 2015-2024, abbia invocato la legislazione in deroga del post-Vaia. Ciò per riproporre il collegamento stradale tra malga Crel e malga Scanaiol, evitando persino di sottoporre il progetto a VINCA, valutazione d’incidenza ambientale, obbligatoria per la disciplina europea in materia di SIC, in mancanza della quale si incorre nell’avvio di procedimenti di infrazione comunitaria dagli esiti potenzialmente assai onerosi.
Il GUFI ritiene illegittimo il ricorso alla legislazione straordinaria invocata per superare l’incompatibilità giuridica gravante a regime di vincolo sull’area e sull’habitat del gallo cedrone, in quanto detta legislazione speciale può essere valida soltanto per consentire l’accesso alle aree boschive danneggiate dall’evento meteorologico eccezionale. Al contrario, la strada in oggetto risulta avere tali caratteristiche solo per poche centinaia di metri iniziali dopo Malga Crel, mentre per il resto del tracciato di progetto le aree con alberi schiantati sono o assenti o del tutto marginali. Risulta che queste considerazioni siano state sollevate in passato anche dall’Ente Parco a motivo del diniego per un’opera così tanto impattante, ma poi all’improvviso le cose sono cambiate.
È accaduto che la giunta esecutiva, organo di amministrazione del Parco, il 17 gennaio 2020, con 4 voti a favore e un astenuto, ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo di “non esprimere, in questa fase emergenziale e straordinaria, alcun parere in merito al piano di gestione forestale aziendale dell’ex Comune di Fiera di Primiero per il periodo 2015-2024, in quanto una parte sostanziale di tale piano contiene la previsione di interventi sia selvicolturali sia infrastrutturali da eseguirsi in emergenza, nell’ambito di quanto stabilito dall’Ordinanza di Protezione Civile provinciale n. 787288 del 28/12/2018 e relativo Piano d’Azione, definiti sulla base quindi di una situazione di emergenza e di atti sovraordinati che esulano dalla ordinaria pianificazione e di conseguenza dall’ambito entro il quale questo Ente deve esprimere il proprio parere ai sensi degli articoli 39 e 57 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11”.
Si ritiene che la posizione assunta dall’amministrazione dell’area naturale protetta sia priva di fondamento: le ordinanze della Protezione Civile sono finalizzate agli interventi urgenti, indifferibili, legati all’emergenza, non altrimenti affrontabili nell’ordinaria amministrazione e nel quadro normativo vigente. Tali ordinanze riguardano quindi fattispecie eccezionali e non sono certo finalizzate alla realizzazione di opere stabili, non di servizio né tantomeno provvisorie, ordinarie e al di fuori delle operazioni emergenziali. Un’interpretazione fallace in questo senso è oggettivamente volta al solo scopo di aggirare il quadro normativo esistente a livello provinciale, statale ed europeo, e per giunta dopo che tale progetto era stato respinto ripetutamente e motivatamente dallo stesso Ente Parco.
Si sottolinea l’assurda situazione che rischia di verificarsi, per cui in una zona in cui parte della foresta è stata devastata dalla tempesta Vaia, con le ordinanze conseguenti della Protezione Civile, si prevede lo scempio ulteriore della parte di foresta a Paneveggio che era stata scarsamente interessata dalla tempesta e si era sostanzialmente salvata. Lo sfregio questa volta deliberato, prevedibile ed evitabile, eseguito sotto lo scudo della Protezione Civile, sarebbe però permanente, trattandosi di una strada che provoca consumo irreversibile di suolo, frammentazione e disturbo di habitat pregiati di alta quota, che – secondo la letteratura scientifica e secondo le stesse pubblicazioni del Parco – sono in cima alle cause del rischio di estinzione del gallo cedrone.
La sventurata noncuranza degli aspetti basilari ecologici ed ambientali che caratterizza quanto sta accadendo, addirittura in un’area naturale protetta, è testimoniata anche da fatto, aggravante e veramente inammissibile, che i lavori sono iniziati in periodo di riproduzione della fauna in generale e in particolare proprio nel periodo più critico per il gallo cedrone. Si richiama, per tutte le numerose prese di posizione del mondo scientifico in materia di protezione di questa specie, il convegno organizzato dal Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino l’11 ottobre 2011, proprio sull’aspetto riproduttivo del tetraonide durante il quale la professoressa Storch ha, tra l’altro, fornito alcune raccomandazioni accorate di carattere generale in tema di gestione. Si tratta, ha sostenuto, di evitare soprattutto il disturbo durante il periodo della cova e dell’allevamento dei pulli, perché i piccoli di gallo cedrone sono molto vulnerabili. In particolare, fra gli aspetti concreti, ha suggerito di non prevedere utilizzazioni forestali in tali periodi e di attuare misure di contenimento di altre forme di disturbo antropico.
Si richiama a riguardo l’art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i., che comporta in favore di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri” (art. 1 della direttiva) “il divieto: a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva. Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato (artt. 544 ter cod. pen., 30, comma 1°, lettera h, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) o violazioni di carattere amministrativo (art. 31 della legge n. 157/1992 e s.m.i.).
Il GUFI chiede pertanto di riconsiderare le autorizzazioni date, di interrompere immediatamente i lavori, che venga disposto il ripristino, per quanto possibile, dello stato ex ante dei luoghi finora interessati dal cantiere e di non procedere ulteriormente alla realizzazione di un’opera di tale impatto ambientale, portata all’attuazione con procedure ingiustificate ed ingiustificabili extra ordinem, che potrebbero configurarsi come abusi ed essere forieri di danno ambientale ex art. 18 della legge 349/86 nonché di severi provvedimenti dell’Unione Europea.
Si riserva pertanto ogni iniziativa legale consentita dall’ordinamento, in sede nazionale ed europea, qualora l’intervento dovesse essere portato a compimento, e si incoraggia la popolazione trentina a far sentire la propria voce con le istituzioni responsabili in difesa del loro prezioso patrimonio naturale.

da Valentina Venturi | 1 Giu, 2020 | Biomasse, Energia, Foreste, Inquinamento, Salute
L’associazione GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane appoggia la richiesta portata avanti da diverse associazioni di sospensione della riapertura della centrale a biomasse di Mercure. La megacentrale collocata nel Parco Nazionale del Pollino brucia 350.000 tonnellate di legno vergine all’anno (frutto del taglio di centinaia di migliaia di alberi) per produrre energia elettrica: una modalità di produzione di energia che l’Italia deve abbandonare per quattro importanti ragioni.
In primis, bruciare biomasse forestali accelera il riscaldamento globale: le energie da biomasse legnose sono più climalteranti persino delle energie fossili poiché, a parità di energia prodotta, emettono il 150% di CO2 rispetto al carbone e il 300% rispetto al gas naturale (da “Letter From Scientists To The Eu Parliament Regarding Forest Biomass” del gennaio 2018), mentre il riassorbimento di equivalenti quantità di CO2 da parte di nuovi alberi richiederà molti decenni: un tempo che non abbiamo a disposizione. Il taglio di un numero così elevato di alberi va ad aggravare il riscaldamento globale di cui una delle concause principali è proprio la deforestazione. Per rimuovere la CO2 accumulata abbiamo bisogno di grandi alberi e delle foreste vergini, che la assorbono oltre 50 volte in più rispetto ai nuovi alberi e alle piantagioni.
Secondo, la combustione di biomasse forestali presenta un grave rischio per la salute dei cittadini, in particolare in una zona come la Valle del Mercure, dove i fumi di combustione ristagnano a lungo a causa del fenomeno dell’inversione termica. La combustione di tutte le biomasse legnose, secondo i dati ufficiali dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) e di ISPRA, per la sola emissione in atmosfera di PM2,5, causa in Italia circa 20.000 morti premature ogni anno, senza contare le patologie dovute alle emissioni di inquinanti emessi nella combustione del legno (arsenico, mercurio, diossina, furani, IPA…). L’Italia detiene il triste record in Europa per morti premature derivanti dalla cattiva qualità dell’aria.
Terzo, l’utilizzo delle biomasse legnose come fonte di energia minaccia le foreste. Il patrimonio boschivo italiano è ormai sfruttato intensivamente e ben oltre i limiti di rigenerazione dello stesso. Un disastro ecologico che compromette gravemente gli ecosistemi forestali, privando le specie animali e vegetali del loro habitat, e che ha effetti anche sulla popolazione, in quanto la conservazione del patrimonio forestale è essenziale per la stabilità del suolo e la regimazione delle acque.
Quarto, il rapporto presente tra la distruzione di habitat naturali – soprattutto forestali – e l’innesco di epidemie causate dalla migrazione degli animali selvatici cacciati dal loro habitat. Virus di cui gli animali sono portatori possono fare il salto di specie e infettare l’uomo. È avvenuto con Hersa in Australia, arrivata dai pipistrelli, che si è diffusa prima tra i cavalli per poi passare all’uomo; con Ebola in Africa, dove i cercatori d’oro hanno disturbato la foresta casa di diverse specie di primati; con la malattia di Lyme negli USA, dove la scomparsa dei boschi ha decimato i predatori degli artropodi e causato un forte aumento delle zecche che trasmettono la malattia all’uomo; e in tantissimi altri casi riportati nella bibliografia scientifica e nell’ormai noto best seller Spill Over di David Quammen.
La produzione di energia da combustione di biomasse legnose non può quindi essere considerata energia pulita, non dovrebbe poter usufruire di generosi incentivi economici, e andrebbe abbandonata al più presto per la salute del pianeta, dei cittadini e per la nostra sicurezza sanitaria e sociale. GUFI è per un utilizzo razionale e sostenibile del legno, ottenuto da selvicoltura ecologica e in boschi destinati all’uopo, e per qualsiasi prodotto in cui il carbonio in esso contenuto resti allo stato solido.

da Valentina Venturi | 21 Apr, 2020 | Difesa Foreste, Foreste
A seguito di due scandalosi servizi andati in onda sul TG1 e sul TG3 Regione Toscana, dove i boschi venivano equiparati a campi da coltivare, il GUFI – in coro con molte altre associazioni – ha inviato alla RAI la seguente lettera.
Il bosco non ha bisogno dell’uomo, è l’uomo che ha bisogno del bosco
Le associazioni firmatarie protestano per un approfondimento andato in onda sul TG1 sul tema della selvicoltura. La RAI è un servizio pubblico e non dovrebbe dare spazio ad affermazioni antiscientifiche: sostenere che le foreste abbiano bisogno di manutenzione è un’assurdità.
Roma, 20 aprile 2020 – Le associazioni promotrici GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane, ISDE Italia – Medici per l’ambiente, Italia Nostra Abruzzo, Italia Nostra Friuli Venezia Giulia, Italia Nostra Lazio, Italia Nostra Marche, Italia Nostra Toscana, Italia Nostra Veneto, ALTURA – Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti, insieme alle altre associazioni firmatarie, manifestano sconcerto per le affermazioni antiscientifiche alle quali il servizio pubblico RAI ha dato spazio nel servizio andato in onda il 14 aprile sul TG1, in cui alcuni operatori addetti al taglio boschivo (quindi non scienziati) hanno fatto una serie di affermazioni false, sostenendo che per la salute dei boschi sia indispensabile una manutenzione costante. Addirittura viene sostenuto che il bosco avrebbe bisogno, per rimanere in salute, dell’intervento regolare dell’uomo che tagli gli alberi più vecchi per lasciare posto ai giovani, lasciando intendere che un bosco dove non si tagliano alberi non sarebbe in grado di rigenerarsi e finirebbe per morire. Nel servizio si lamenta che i nostri boschi, a causa della quarantena, sarebbero rimasti senza “manutenzione” per un mese, affermando che il bosco non sia diverso da un “campo ordinario” e vada quindi “coltivato”.
Le associazioni ricordano che le prime foreste sono comparse sul nostro pianeta circa 350-400 milioni di anni fa. L’essere umano (inteso come Homo sapiens) vive sulla Terra da poco più di 200mila anni. È quindi lapalissiano che le foreste si siano evolute e siano sopravvissute per centinaia di milioni di anni senza alcun intervento da parte dell’uomo, e hanno invece prosperato e coperto gran parte delle terre emerse. Chiunque abbia avuto l’ormai raro privilegio di camminare in una foresta vetusta, antica e poco disturbata dalla mano dell’uomo, capisce intuitivamente quanto sia arrogante e antropocentrico pensare che ecosistemi così complessi e ricchi di biodiversità, frutto di milioni di anni d’evoluzione, possano avere bisogno dell’intervento costante dell’ultima specie arrivata per prosperare.
Il bosco è un ecosistema, e come tutti gli ecosistemi è autosufficiente e attraverso complesse relazioni tra piante, animali, funghi e batteri che vivono al suo interno crea un equilibrio perfetto dove ogni suo abitante trova riparo, nutrimento e ciò che occorre alla sopravvivenza della sua specie. L’uomo non fa eccezione: anche noi abbiamo bisogno del bosco per trarne ciò che ci serve per vivere. La differenza sta nel fatto che l’uomo non si ferma dopo aver prelevato il necessario: supportato dalla tecnologia e spinto da interessi economici ha un potenziale distruttivo sconosciuto alle altre specie e può alterare l’equilibrio di un ecosistema, anche fino alla sua scomparsa.
In un momento in cui l’opinione pubblica – per merito del costante lavoro degli scienziati e della voce dei nostri giovani che si alza dalle piazze – comincia a prendere coscienza dell’impatto umano sul pianeta, è grave che il servizio pubblico televisivo dia spazio solo a chi i boschi li taglia per profitto: il conflitto di interesse è evidente. Se è vero che l’uomo ha bisogno di prelevare del legname per le sue necessità, questo dimostra solo che siamo noi a essere dipendenti dalle foreste, e non certo il contrario: una dipendenza di cui dobbiamo tenere conto nel momento in cui decidiamo quanto e cosa tagliare. Le foreste, oltre a costituire la nostra migliore arma nella lotta al cambiamento climatico, sono fondamentali per la salute umana. Come ricorda il WWF in un comunicato del mese scorso, la deforestazione e la perdita di habitat sono tra i fattori più rilevanti nella nascita delle pandemie.
È quindi giunto il momento di sgombrare definitivamente il campo dalle fake news diffuse da chi vede i boschi solo con gli occhi del profitto economico, e porre fine allo sfruttamento intensivo (quella che viene chiamata “manutenzione”) che vede i boschi italiani sempre più sotto pressione a beneficio della produzione di energia elettrica da biomasse forestali, mentre la produzione di mobili, invocata nel servizio, utilizza solo una piccola parte della produzione nazionale di legname. Se è vero che la mera superficie dei boschi italiani è in aumento, va ricordato che il punto di partenza da cui si calcola questo aumento è il minimo storico di superficie raggiunto nel secondo dopoguerra; che tutt’ora l’Italia si colloca al di sotto della media europea per percentuale di superficie boscata; che siamo sotto la media europea anche per quanto riguarda la percentuale di territorio protetto.
La “manutenzione” invocata dalle ditte che vendono legname è sovente una vera e propria devastazione che asporta il sottobosco e il legno morto – entrambi parte integrante dell’ecosistema foresta e indispensabili per la sopravvivenza di moltissime specie animali e vegetali – e taglia gli alberi più grandi, lasciando un terreno spoglio dove sparuti giovani alberi sono gli unici superstiti in una landa desolata. Per le statistiche nazionali sarà ancora una foresta, ma ridotta in quelle condizioni di fatto non lo è più. Un terreno così spogliato costituisce inoltre un grave rischio per la sicurezza idrogeologica.
Deve essere quindi chiaro all’opinione pubblica che la selvicoltura risponde a una necessità dell’uomo, come le automobili e l’estrazione di petrolio, ma NON è una necessità delle foreste; che nel prelevare il legname ci si deve porre al di sotto dei limiti di tolleranza (resilienza) della foresta stessa, dandole modo e tempo di rigenerarsi; che per la salute nostra e del pianeta è indispensabile che una parte rilevante del territorio sia protetta e lasciata alla sua evoluzione naturale, affinché la foresta possa fornire tutti quei benefici ecosistemici che non solo costituiscono un habitat per le altre specie, ma ci garantiscono aria e acqua pulite, prevengono il dissesto idrogeologico e ci aiutano a combattere il riscaldamento climatico, di cui una delle cause principali è proprio la deforestazione.
Le associazioni si augurano quindi che i media forniscano un’informazione corretta e supportata dalla scienza ai cittadini italiani e chiedono alla Rai di poter replicare al servizio andato in onda, mettendo a disposizione i loro scienziati per un’intervista.
Cordialmente,
le Associazioni
GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane; ISDE Italia – Medici per l’ambiente; Italia Nostra Abruzzo; Italia Nostra Friuli Venezia Giulia; Italia Nostra Lazio; Italia Nostra Marche; Italia Nostra Puglia; Italia Nostra Toscana; Italia Nostra Veneto; ALTURA – Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti; Navdanya International; Amici del Cansiglio; ABC Associazione beni comuni La Rete; Acqua Bene Comune Pistoia; ADA ONLUS Associazione Donne Ambientaliste; Alleanza Beni Comuni Pistoia; AsOER – Associazione degli Ornitologi dell’Emilia-Romagna ODV; Associazione culturale AmbienteScienze; Associazione Culturale Blow-up; Associazione Mani Libere Civitanova Marche; Associazione Solidarietà e Partecipazione – Castrovillari; Biodistretto Montalbano; Casacomune Scuola e Azioni; Centro Parchi Internazionale; CISDAM – Centro Italiano Studi e Documentazione sugli Abeti mediterranei; Co.n.al.pa. Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus; Comitato Intercomunale Silla2; Comitato per il Bene Comune Sovizzo; Diritto Diretto Onlus; Ecoistituto Abruzzo; Ecoistituto Cesena; Ecomuseo Montagna Fiorentina; European Consumers; Goodland; Federazione Nazionale ProNatura; Forum Ambientalista; GPSO – Gruppo Piemontese Studi Ornitologici “F.A. Bonelli” Onlus; GriG – Gruppo d’intervento Giuridico; Gruppo dei Trenta; Gruppo Promotore Parco del Cadore; Insilva; Io non ho paura del lupo; Istituto Italiano di Permacultura; La Cabalesta – Associazione Terra Boschi Gente e Memorie; LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia); Le Giardiniere; Liberi Pensatori a Difesa della Natura; LIPU Abruzzo; LIPU Firenze; LIPU Grosseto; LIPU Pistoia; Lupus In Fabula; Mamme No Inceneritore (Firenze); Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus; Marevivo Abruzzo; MEDIPERlab Permacultura Mediterranea; Mila Donnambiente; Mountain Wilderness International; Movimento Tutela Alberi Firenze; Pro-Rights; RAMI – Registro degli Alberi Monumentali Italiani; Rewilding Apennines; Salviamo L’Orso ONLUS; SIMEF – Società Italiana di Medicina Forestale; Smilax Nova; Società Italiana per la Storia della Fauna; STAI-Stop Taglio Alberi Italia; Stop 5G Castel di Lama; Stop 5G Civitanova Marche; Stop 5G Marche; Terra Nuova Edizioni; Unione Bolognese Naturalisti; UNI-VERSO Amiata; VAS – Vita Ambiente e Salute ONLUS (Firenze); WWF Toscana; WWF Emilia-Romagna
I dati sulla superficie forestale media dell’Unione Europea sono presi dal sito del Parlamento Europeo e sono consultabili a questo link: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/105/l-unione-europea-e-le-foreste

da Livia Schirone | 14 Apr, 2020 | Biomasse, Clima, Difesa Foreste, Energia, Foreste, Inquinamento, Salute
ISDE Italia – Medici per l’Ambiente e GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane chiedono alle istituzioni di non autorizzare la ripresa dei tagli boschivi, un’attività che nel caso delle latifoglie è anche fuori tempo massimo: è ormai primavera e i tagli nei boschi di latifoglie sono vietati per consentire alle piante il periodo vegetativo. Aperta una petizione su Change.org.
Roma, aprile 2020 – GUFI e ISDE chiedono alle istituzioni di non accogliere la richiesta avanzata da CONAIBO (Coordinamento nazionale delle imprese boschive), AIEL (Associazione italiana energie agroforestali), Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) e alcuni Comuni montani di riaprire le attività di taglio degli alberi in deroga alla quarantena, e hanno aperto una petizione sul sito Change.org per chiedere il sostegno dei cittadini che hanno a cuore l’ambiente e la salute pubblica.
Le attività forestali sono infatti ferme in quanto considerate non necessarie, e nel momento in cui l’Italia ripartirà sarà concesso solo, fino al prossimo inverno, il taglio dei boschi di conifere. Questo perché nei boschi di latifoglie (querce, faggi, carpini…) non è concessa l’attività di taglio durante il periodo vegetativo, cioè quando le piante hanno già messo le foglie. Tagliare le latifoglie in primavera, tramite la tecnica del ceduo che rimuove il tronco dell’albero lasciando solo un ceppo da cui nascono nuovi polloni, le danneggerebbe gravemente con evidenti ricadute sugli ecosistemi. Il taglio delle foreste di conifere (pini, abeti) è invece concesso tutto l’anno, perché nel loro caso la tecnica del ceduo non si può utilizzare e la riproduzione avviene unicamente tramite seme.
Le associazioni dei tagliatori non stanno quindi chiedendo solo di violare la quarantena a cui sono sottoposte tutte le altre aziende, ma anche di poter violare la legge che protegge i boschi di latifoglie, tagliando a primavera ormai giunta: quest’anno, infatti, la stagione risulta particolarmente anticipata, a seguito di quello che è stato l’inverno più caldo di sempre in Europa (3,4 gradi in più rispetto alla media del periodo).
Perché questo accanimento?
È importante ricordare che in Italia è in corso da anni un vero e proprio assalto alle foreste, viste non come bene prezioso per il pianeta, per la salute dei cittadini e come arma contro il riscaldamento globale, ma unicamente come fonte di energia. Il proliferare in Italia di centrali a biomassa, che bruciano legno per produrre energia elettrica, ha scatenato una vera e propria corsa al taglio. Le nostre foreste, che per mera superficie sono in aumento, vengono gravemente impoverite e compromesse da continui tagli che interessano gli alberi più grandi: un diradamento che, se lascia intatta la superficie della foresta, di fatto la spoglia quasi completamente riducendola a pochi alberi giovani e sottili, distanti tra loro. Una devastazione evidentissima anche a un occhio non esperto (si allega foto di una foresta governata a ceduo).
GUFI e ISDE ricordano che bruciare il legno provoca maggiori emissioni di CO2 e di polveri sottili persino rispetto all’utilizzo dei combustibili fossili, con ricadute drammatiche in termini di contrasto al cambiamento climatico e di impatto sulla salute. Le biomasse forestali non possono essere considerate una fonte rinnovabile di energia: anche piantando un albero in sostituzione di quello tagliato, questo impiegherà anche un secolo ad assorbire le emissioni di quello abbattuto, sempre ammesso che non venga tagliato prima – un lasso di tempo che non ci è concesso prenderci nella lotta al riscaldamento globale e per la conservazione della biodiversità. Non a caso, due anni fa ben 784 scienziati hanno scritto al Parlamento Europeo per segnalare che usare legna come combustibile accelererà il cambiamento climatico, mentre sempre più studi rivelano l’importanza delle foreste mature e intatte nella lotta al riscaldamento globale. Inoltre, come evidenziato da un comunicato stampa del WWF a marzo, esiste uno strettissimo legame tra pandemie e danni all’ecosistema.
La richiesta delle associazioni dei taglialegna di riprendere le attività in violazione della quarantena e addirittura di prolungare il taglio delle latifoglie anche durante il periodo primaverile è causato dal desiderio di placare la fame insaziabile delle centrali a biomassa, per le quali il solo legno di conifera tagliato al termine della quarantena parrebbe non sufficiente. Eppure, come fatto notare dagli stessi promotori della richiesta di deroga alla quarantena, rimangono a terra milioni di tronchi schiantati dalla tempesta Vaia, che stanno venendo acquistati da imprese austriache proprio per produrre legna da ardere. Il recupero del legno schiantato dalla tempesta (che giace lì da moltissimi mesi, quindi non si comprende l’urgenza) può essere autorizzato con un provvedimento ad hoc, senza riprendere i tagli su tutto il territorio nazionale. Trattandosi di conifere, inoltre, il prelievo di questi alberi potrà riprendere immediatamente dopo la fine della quarantena, anche se andrà fatto con oculatezza per evitare l’erosione del terreno e il conseguente rischio idrogeologico.
Non vi è inoltre alcun rischio di esaurimento a breve termine delle scorte di legno, dato che quelle per il prossimo inverno sono già state approntate e non sarà eventuale legna raccolta ora, ancora verde, ad aumentarle. Inoltre in questo momento sono chiusi alberghi di montagna, ristoranti, rifugi, pizzerie ed altri esercizi che fanno grande consumo di legna da ardere: il fabbisogno di legna nell’ultimo mese è crollato.
Le imprese e le loro associazioni lamentano inoltre la necessità di produrre imballaggi di legno (pallets) per i settori fondamentali. I pallets però vengono prodotti perlopiù con il legno delle conifere: non c’è quindi ragione di tagliare le latifoglie in deroga alle norme ambientali. Inoltre i pallet sono riutilizzabili. Il settore agroalimentare non utilizza pallets ma contenitori di plastica, e lo stesso vale per i prodotti farmaceutici. Non ci sono quindi attività essenziali che abbiano bisogno di un’immediata produzione di pallets.
Inoltre è legittimo chiedersi in quali condizioni sanitarie le aziende di taglio vorrebbero far operare i loro lavoratori durante la pandemia: sono tristemente note le continue violazioni delle norme basilari di tutela dei lavoratori nel settore dei tagli boschivi, dove è inoltre ampiamente diffuso il lavoro nero.
In conclusione, GUFI e ISDE ritengono che non vi sia alcuna ragione per ritenere il taglio di alberi come attività necessaria che meriti una deroga durante la quarantena; che eventuali (e da dimostrare) necessità di legname possano essere soddisfatte utilizzando il legno schiantato dalla tempesta Vaia tramite un provvedimento ad hoc, che non includa le altre foreste sul territorio italiano; e che la richiesta di riaprire il taglio nei boschi di latifoglie in deroga alle leggi a protezione dell’ambiente sia irricevibile.
GUFI e ISDE invitano tutti i cittadini che hanno a cuore la salute e l’ambiente (e conseguentemente la propria) a firmare la petizione “Taglialegna #stateacasa” sul sito Change.org all’indirizzo: http://chng.it/g9zHLWXc
CONTATTI
Valentina Venturi – Ufficio stampa GUFI
Mail: press@gufitalia.it | Tel: 3403386920

da Livia Schirone | 9 Feb, 2020 | Clima, Energia, Foreste, Inquinamento
Non è un film che ricorda Fritzcarraldo (di Herzog, 1982) ove l’eroico inseguimento della realizzazione di un sogno colossale viene portato avanti ad ogni costo e a prezzo di sacrifici incredibili. E’ una proposta vera che a noi non convince.
Il 5 di Febbraio un’equipe del Politecnico di Milano ha presentato una ricerca finalizzata ad abbattere l’eccesso di CO2 in atmosfera per contrastare la crisi climatica: il metodo sarebbe quello di spandere nell’intero mar Mediterraneo e in prospettiva negli oceani del pianeta Terra, magari approfittando di un “passaggio” offerto dalle navi che attualmente viaggiamo per il globo, calce idrata (idrossido di Calcio).
Vediamone i fondamenti.
L’anidride carbonica, si sa, è in massima parte assorbita dai mari e dagli oceani non solo perchè in quanto gas si discioglie in acqua ma anche perché reagendo con essa, in buona misura cambia stato: smette di essere gas e si trasforma in acido carbonico. Questo si ionizza dando luogo a una reazione di equilibrio che complessivamente può essere così rappresentata: CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + 2 HCO3– . In pratica la CO2 non si comporta come un gas qualsiasi, ad esempio al pari dell’ossigeno, che si scioglie in acqua fino a quando la sua concentrazione è arrivata a saturazione (per la legge di Henry) e resta lì come ossigeno disciolto. La reattività della CO2 una volta entrata in acqua la fa sparire dallo stato gassoso, in quantitativi significativi, e la fa trasformare soprattutto in ione idrocarbonico (vale a dire in bicarbonato) così liberando “spazio” per lo scioglimento in acqua di altra anidride carbonica. Se a questo equilibrio sottraiamo lo ione idrocarbonico, realizziamo una forzante per cui altra CO2 verrà assorbita dall’aria, e andrà a disciogliersi in quelle acque ove si è liberato spazio. In definitiva tanto più sottraiamo ione idrocarbonico dai nostri mari e tanto più liberiamo spazio perché questi possano assorbire CO2. Ma come sottrarre, a costi non proibitivi in assoluto, lo ione idrocarbonico? Semplice, lo sappiamo da oltre un secolo: basterebbe somministrare calce per trasformarlo in Carbonato di Calcio:
Ca(OH)2 + H2CO3 → CaCO3 + 2 H2O
.
Calce spenta+ ac. Carbonico → Carbonato di Calcio + acqua
In questo modo il carbonato di
Calcio, insolubile, precipiterebbe verso i fondali.
Fin qui sembra tutto facile ma la fattibilità è altra cosa. Gli stessi autori della ricerca, Stefano Caserini, noto per il suo impegno nella lotta alla crisi climatica, e Mario Grosso, dicono che occorrono altre ricerche, anche in relazione all’impatto ambientale.
Le nostre severe perplessità riguardano:
Il materiale di base.
Per produrre calce, in quantitativi così elevati, occorrerebbe realizzare cave gigantesche di roccia carbonatica. Forse servirebbero montagne intere. E conseguenti impiego di esplosivi, di macchine operatrici, di camion per il trasporto, di mulini di triturazione, il tutto per tempi lunghissimi.
La produzione della calce (Ossido di Calcio) richiede tantissima energia.
L’idrossido di calcio si ottiene dalla calce e questa a sua volta si ottiene “cuocendo” la roccia carbonatica frantumata, a 900-1000° C: dove prendiamo l’imponente quantitativo di energia necessaria? Se la risposta fosse (com’era stato ventilato per quella ricerca) che la prendiamo dalle biomasse forestali, siamo di fronte ad un assunto errato secondo cui bruciare legna sarebbe a bilancio neutro rispetto alla CO2; sappiamo che non è così: questa è una pratica fortemente emissiva, climalterante oltre che tra le più inquinanti. E sottrarrebbe alla terraferma gran parte delle foreste che assorbono – gratuitamente- CO2 fissandola a terra nel legno, nelle radici, nella lettiera, nell’humus (la maggior parte!) e nel ciclo sotterraneo delle acque. Occorre tenere in conto, rispetto alla questione climatica, anche e soprattutto il fattore tempo: quando bruciamo un albero di 70 anni, ad esempio, le emissioni di anidride carbonica in atmosfera sono praticamente immediate e andiamo a peggiorare la situazione climatica già alterata… ma perché un albero piantato per sostituire quello bruciato possa svolgere la stessa funzione di assorbimento di CO2, occorre che cresca, che passino svariati decenni e noi tutto questo tempo per agire non lo abbiamo. E’ necessario ridurre ora le emissioni. Per non parlare del disastro che si avrebbe ai danni della biodiversità e degli ecosistemi connessi.
La cottura delle rocce libera essa stessa tanta CO2
CaCO3 + calore → CaO + CO2 .
Ovvero: ogni molecola di calce viva (CO da cui si ricava l’idrossido di Calcio) prodotta, ne libera una di anidride carbonica! In termini di massa questo vuol dire che ogni tonnellata di calce viva prodotta libera 846 chilogrammi di CO2. Questa emissione andrebbe ad aggiungersi a quella prodotta per il calore. E’ evidente che occorrerebbe trovare un sistema aggiuntivo (dispendioso e costoso) per sequestrare questa produzione imponente di CO2 che per certo non può essere liberata in atmosfera. Che farne? Iniettarla, attivando compressori (energivori) nelle profondità della terra? Magari in suoli vulcanici che la immobilizzano? In quantitativi imponenti, ove troviamo tanto spazio di deposito?
La trasformazione dell’ossido di Calcio in calce idrataè anch’essa problematica.
È una reazione semplice (basta immettere l’ossido di calcio nell’acqua) ma piuttosto violenta, che libera forti quantità di calore e quindi occorrerebbero impianti adeguati da cui magari si potrebbe recuperare il calore prodotto. Poi l’idrossido di calcio dev’essere trasportato fino alle navi e poi per i mari (tal quale, così trasportando anche l’acqua con i relativi costi? Oppure disidratato ma a spese di altre fonti di energia per essere poi reidratato in mare?).
Lo spandimento in mare non garantisce una omogeneizzazione della calce su larghe superfici.
Si rischia di avere aree ad alta concentrazione di calce che danneggi la flora e la fauna marina pelagiche. La diffusione, si sa, è un fenomeno lentissimo e questo rischio è assai concreto soprattutto in condizioni di mare calmo.
Il rischio di inquinamento da materiali solidi in sospensione e poi sedimentabili.
Come esito dello spandimento della calce si produce carbonato di calcio, praticamente insolubile, che tende a precipitare assai lentamente. In definitiva in mare si formerebbe una polvere sottilissima, biancastra, della stessa natura chimica della roccia finemente triturata fino a livello molecolare, che tende a stratificare nel tempo verso il fondo. Questa polvere tende ad aggregarsi come avviene in natura quando si formano rocce sedimentarie. Il rischio più forte che questo fenomeno potrebbe produrre è quello di seppellire le forme di vita bentonica ma, ancora di più, di intasare le branchie e gli apparati respiratori di tutti gli organismi filtratori. I molluschi lamellibranchi, ad esempio, sono sensibilissimi ai fenomeni di inquinamento fisico che comportino il cambio della granulometria dei fondali in cui sono immersi o ancorati e la loro scomparsa per soffocamento si rifletterebbe fino a vertici delle catene e delle reti alimentari.
Si andrebbe ad agire su un equilibrio planetario: occorre molta cautela.
Lo ione idrocarbonico contribuisce a contrastare le modifiche di pH delle acque: è in definitiva un “tampone”. L’immissione di calce effettivamente correggerebbe l’acidificazione che la CO2 ha prodotto nei nostri mari con danni incredibili in atto, i cui effetti più vistosi sono riscontrabili nello sbiancamento delle barriere coralline e morte dei coralli. Ma questa “correzione”, peraltro di dimensioni planetarie, richiederebbe ingentissimi quantitativi di idrossido di Calcio e poi ha un punto di arrivo certo, giusto e misurabile come riferimento?
Problemi di diritto internazionale.
Agire su mari che bagnano una moltitudine di nazioni, con una operazione di scala planetaria, non è cosa facile: non c’è solo la questione dei costi su cui la ricerca appare concentrata, ma occorrerebbero consensi vastissimi, convenzioni e collaborazioni difficilmente ottenibili. Inoltre tutta quella calce occorrente non sarebbe producibile solo in Italia…
CONCLUSIONI
Con tutto il rispetto per la Ricerca che noi di GUFI sosteniamo e riteniamo non sia mai abbastanza, e con il sincero rispetto per persone come Caserini e Grosso impegnati come pochi nella lotta alla crisi climatica, riteniamo che la strada intrapresa sconti un peccato di riduzionismo, sia francamente eccessiva nei propositi e che rechi un rischio aggiuntivo, che sarebbe epocale, per le nostre foreste qualora fossero confermate come fonte energetica. I boschi e le foreste non sono un insieme di alberi e serbatoio di energia producibile come calore: sono ecosistemi che regolano la vita di tutta la Terra. Noi riteniamo che gli alberi, i boschi e le foreste evolute siano invece i nostri principali alleati nella lotta al riscaldamento globale. E che quindi vadano lasciati il più possibile a svolgere le loro funzioni ecologiche, e i loro benefici ecosistemici, anche sulla salute.

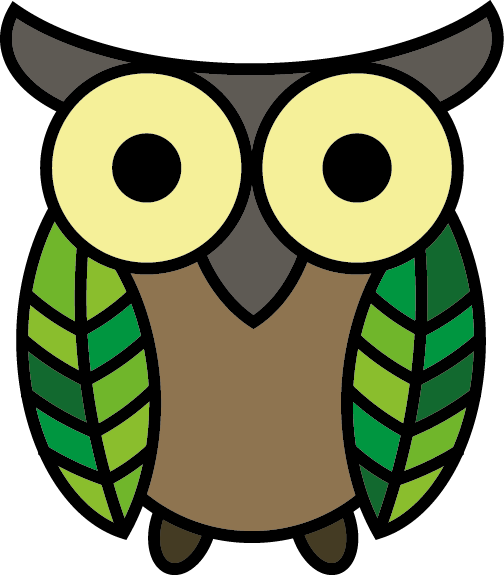





Commenti recenti