
da Valentina Venturi | 3 Ago, 2023 | Biomasse, Energia, Foreste, Uncategorized
L’associazione GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane applaude la decisione della Giunta Regionale della Calabria e del suo Presidente, Roberto Occhiuto, che ha approvato il Piano del Parco Nazionale del Pollino senza concedere deroghe alla potenza della centrale del Mercure, grande impianto che produce energia elettrica bruciando biomasse forestali.
Il Piano del Parco prevede la presenza di centrali a biomasse fino alla potenza di massima di circa 2,7 MWe, escludendo quindi la megacentrale che ha una potenza circa 15 volte superiore.
“Il Pollino, perciò, non ospiterà più megacentrali a biomasse, pericolose per la salute dei cittadini e per l’ambiente, ma anche per lo sviluppo turistico ed economico dell’area protetta più grande d’Italia, che è anche tutelata dall’UE in quanto ZPS, nonché patrimonio UNESCO, e che dunque non può inseguire una impossibile e perniciosa pseudo-industrializzazione, utile soltanto alla proprietà della centrale e dannosa, sotto ogni aspetto per le popolazioni residenti che tante volte ed in maniera partecipatissima si sono mobilitate contro la centrale”, dice Ferdinando Laghi, consigliere regionale e membro delle associazioni ISDE e GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane-, che combatte contro la centrale da oltre 20 anni, a difesa delle foreste italiane e della salute dei cittadini calabresi e lucani.
La megacentrale collocata nel Parco Nazionale del Pollino brucia circa 350.000 tonnellate di legno vergine all’anno (frutto del taglio di centinaia di migliaia di alberi) per produrre energia elettrica: una modalità di produzione di energia – in una regione che produce circa tre volte l’energia di cui necessita e a cui la centrale del Mercure contribuisce per appena lo 0,0002 % — che l’Italia deve abbandonare per tre importanti ragioni.
In primis, bruciare biomasse forestali accelera il riscaldamento globale: le energie da biomasse legnose sono più climalteranti persino delle energie fossili poiché, a parità di energia prodotta, emettono il 150% di CO2 rispetto al carbone e il 300% rispetto al gas naturale (da “Letter From Scientists To The EU Parliament Regarding Forest Biomass” del gennaio 2018), mentre il riassorbimento di equivalenti quantità di CO2 da parte di nuovi alberi richiederà molti decenni: un tempo che non abbiamo a disposizione. Il taglio di un numero così elevato di alberi va ad aggravare il riscaldamento globale di cui una delle concause principali è proprio la deforestazione. Per rimuovere la CO2 accumulata abbiamo bisogno di grandi alberi e delle foreste vergini, che la assorbono oltre 50 volte in più rispetto ai nuovi alberi e alle piantagioni.
Secondo, la combustione di biomasse forestali presenta un grave rischio per la salute dei cittadini, in particolare in una zona come la Valle del Mercure, dove i fumi di combustione ristagnano a lungo a causa del fenomeno dell’inversione termica. La combustione di tutte le biomasse legnose, secondo i dati ufficiali dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) e di ISPRA, per la sola emissione in atmosfera di PM2,5, causa in Italia circa 20.000 morti premature ogni anno, senza contare le patologie dovute alle emissioni di inquinanti emessi nella combustione del legno (arsenico, mercurio, diossina, furani, IPA…). L’Italia detiene il triste record in Europa per morti premature derivanti dalla cattiva qualità dell’aria.
Terzo, l’utilizzo delle biomasse legnose come fonte di energia minaccia le foreste. Il patrimonio boschivo italiano èormai sfruttato intensivamente e oltre i limiti di rigenerazione dello stesso. Un disastro ecologico che compromette gravemente gli ecosistemi forestali, privando le specie animali e vegetali del loro habitat, e che ha effetti anche sulla popolazione, in quanto la conservazione del patrimonio forestale è essenziale per la stabilità del suolo e la regimazione delle acque.
La produzione di energia da combustione di biomasse legnose non può quindi essere considerata energia pulita, non dovrebbe poter usufruire di generosi incentivi economici, e andrebbe abbandonata al più presto per la salute del pianeta, dei cittadini e per la nostra sicurezza sanitaria e sociale. GUFI è per un utilizzo razionale e sostenibile del legno, ottenuto da selvicoltura ecologica e in boschi destinati all’uopo, e per qualsiasi prodotto in cui il carbonio in esso contenuto resti allo stato solido.
Foto: Di Demincob – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31953639

da Valentina Venturi | 8 Mag, 2022 | Biodiversità, Difesa Foreste, Foreste
di Bartolomeo Schirone
Sugli incendi forestali, come su altri temi che riguardano le foreste, oggi si danno per assunti e scontati alcuni concetti che fino a qualche anno fa non lo erano per nulla. E non mi riferisco all’opinione pubblica in generale, ma proprio al mondo forestale.
Io sono laureato in Biologia, ma ho cominciato ad occuparmi di argomenti forestali quando ero ancora studente universitario e per svolgere delle ricerche bibliografiche frequentavo la biblioteca dell’Istituto di Selvicoltura della mia università. Poi, il mio interesse per quelle discipline aumentò progressivamente fino a farmi decidere che era quello in settore al quale dovevo dedicarmi. Anche perché il mio mentore era Ervedo Giordano, un perfetto professore di selvicoltura scomparso l’anno scorso, la cui cultura generale e apertura mentale nei confronti dei temi scientifici erano veramente rare e nascevano anche dal fatto che aveva davvero viaggiato per mezzo mondo e conosciuto ambienti e persone di ogni tipo1). Eravamo nella seconda metà degli anni Settanta e, a livello europeo, si potevano distinguere nettamente due diversi approcci alla gestione del bosco: quello che per comodità potremmo definire di impostazione tedesca, e che oggi impera nella maggior parte dei Paesi dell’Europa centrale e settentrionale, e quello a prevalente matrice francese.
Nel primo caso, l’impostazione è di tipo economico-produttivistico e interpreta il bosco come una realtà che deve essere dominata, uniformata e quasi geometrizzata per fornire un solo prodotto, quello legnoso, nella maggiore quantità e migliore qualità possibile. A tal fine, l’insieme delle tecniche colturali adottate rendono la selvicoltura nordica qualcosa di veramente molto simile all’agricoltura. In pratica, si taglia il bosco, si ara il terreno e si mettono a dimora nuove piantine forestali tutte uguali e disposte con grande precisione su file parallele, grazie anche alla meccanizzazione spinta di tutte le operazioni. Alla fine del ciclo colturale, il bosco si taglia e si ricomincia daccapo. In effetti, i boschi svedesi o finlandesi, apparentemente molto belli, sono in assoluto tra i più poveri di biodiversità.
Il secondo approccio alla gestione della foresta, che ha visto i francesi tra i massimi teorizzatori, è di stampo decisamente più naturalistico nel senso che cerca, per quanto possibile, di rispettare l’ecologia dei popolamenti forestali e, soprattutto, non prevede l’ossessivo ricorso alla piantagione successiva ai tagli di utilizzazione, ma dà spazio alla rinnovazione naturale del bosco, quella che si genera a partire dai semi liberati dagli alberi stessi.
A questo secondo indirizzo si è sempre ispirata la Scuola Forestale Italiana che, a partire dal primo dopoguerra, aveva già assunto un suo specifico profilo e aveva espresso figure di elevato spessore scientifico a cominciare dal capostipite, quell’Adolfo di Bérenger, tedesco di nascita, francese di famiglia, austriaco di formazione e italiano per cultura e vocazione, che promosse la fondazione del Regio Istituto forestale (inaugurato a Vallombrosa nel 1869 e di cui divenne il primo direttore), segnando l’inizio della selvicoltura in Italia. Ma va subito sottolineato che Di Bérenger non era un semplice forestale: aveva un laurea in filosofia, era poliglotta, era un fine cultore della storia e della letteratura greca e latina che studiava direttamente dai testi in lingua originale, aveva un diploma in Scienze Naturali, era un capace botanico e un ecologo sapiente tanto da intrattenere proficui rapporti culturali – e di amicizia personale – con George Perkins Marsch, considerato da molti come il primo ecologista americano, il quale giunto in Italia come ambasciatore degli Stati Uniti, trascorse i suoi ultimi giorni proprio a Vallombrosa.
La Scuola Forestale Italiana nasce, quindi, in un’effervescente e feconda atmosfera culturale in cui il confronto tra forestali, botanici, naturalisti, ecologi e altri intellettuali era continuo, corretto e costruttivo e i ruoli degli uni erano molto spesso scambiabili con quelli degli altri. E devo dire, in tutta onestà, che quest’aria si respirava ancora negli anni Settanta nonostante qualche tendenza all’arroccamento corporativo dei forestali che, negli anni del Fascismo, si erano in qualche modo “militarizzati”, per così dire. Però il dialogo tra esponenti del mondo forestale e di quello dei naturalisti continuava proficuo perché ambedue le categorie avevano come riferimento concettuale e principio informatore delle loro attività la conservazione delle foreste. La differenza di visione si riduceva, per dirla con il mio amico Spada, nell’ordine delle azioni: Conservare per rinnovare vs Rinnovare per conservare.
È certo che l’obiettivo comune a tutti i forestali di quegli anni, docenti universitari o dipendenti dell’Amministrazione Forestale dello Stato era il medesimo: aumentare le provvigioni dei nostri boschi, estenderne le superfici e aumentarne la complessità. Il modello di riferimento, teorizzato da Lucio Susmel, era la fustaia mista disetanea. Si mirava, per quanto possibile, a ridurre le superfici delle tagliate e, pur nella consapevolezza che il governo a ceduo era una realtà inevitabile per alcuni territori, si promuovevano le conversioni. Egualmente, si studiava ancora il carbone da legna, ma la navigazione seguiva la rotta che portava all’incremento della produzione di legname da opera e non di legna da ardere. E che ciò fosse possibile, lo si dimostrava. Non mi stancherò mai di ricordare, infatti, che Parchi nazionali come quello delle Foreste Casentinesi o del Gargano sono stati istituiti per conservare Foreste restaurate, plasmate e sapientemente gestite dai Forestali dell’allora Azienda di Stato per le Foreste Demaniali.
Lo spirito di quei tempi si ritrova ancora negli Atti del Secondo Convegno Nazionale di Selvicoltura tenutosi a Venezia nel giugno del 1998. L’accento è sempre sul valore dei boschi legato alla loro conservazione che sola può garantire un futuro che vada oltre il prodotto. Ad esempio, nella sua mirabile relazione, Alfonso Alessandrini, allora Direttore Generale delle Foreste e dell’Economia Montana presso il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, già parla di progetti di restauro dei boschi italiani, da condurre addirittura con gli industriali del legno per aumentare le provvigioni, per ridare dimensione alle foreste. E gli fa eco, nello stesso convegno, Franco Arquati, industriale del legno, che parla di restauro forestale, conversioni all’alto fusto e occupazione giovanile. Per contro, Alessandrini si scaglia contro la pianificazione ossessiva del territorio e degli interventi forestali. Sue parole: “In Italia c’è un fervore, quasi ossessivo di pianificazione, di carte. C’è il rischio di fatti ripetitivi ed invasivi se non offensivi” e continua parlando di “esigenza di ambiente naturale”.
Tale idea della foresta e del ruolo dei forestali non si è persa del tutto, ma non posso non osservare che accanto a questa scuola di pensiero, ovvero ai suoi ultimi epigoni, ne sta crescendo prepotentemente e con gran vigore un’altra che propone una visione affatto differente, una che arriva a dire che i boschi sono troppi e sottraggono terreno alle attività produttive. La svolta, o diversificazione, come vogliamo chiamarla, si è avuta proprio a partire dall’inizio degli anni Duemila e la ragione non sono riuscito a capirla fino in fondo. Forse è collegata con la nascita e il prodigioso sviluppo delle nuove tecnologie digitali che consentono di fare in brevissimo tempo e con grande comodità operazioni che prima richiedevano grande dispendio di energie. La conseguenza è che il lavoro forestale è diventato sempre più un’attività in smart working non impegnando il ricercatore o il professionista in lunghe “sessioni” in natura. La frequentazione del bosco è diventata un complemento non sempre necessario e non sempre gradito.
Gli esiti di questa nuova visione della foresta si ritrovano tutti nella legge n.34 del 2018 “Testo Unico in materia di Foreste e di Filiere Forestali”, detto TUFF, e nella recente Strategia Forestale Nazionale che ad essa si collega. Si tratta di un provvedimento che, per la prima volta rispetto a tutti i precedenti analoghi, ha suscitato l’indignata protesta del mondo degli ecologi, dei naturalisti e dei botanici a partire da ben tre ex presidenti della Società Botanica Italiana, anche perché nessun rappresentante di queste categorie di esperti è stato chiamato a collaborare alla stesura della legge nonostante non si possa dire, né si era mai detto prima, che il bosco sia di competenza esclusiva dei forestali. Ma alla protesta si sono uniti anche non pochi vecchi forestali e docenti, compreso il sottoscritto, per l’impronta produttivistica di stile nordico posta al centro delle attività forestali.
Ma cosa c’è di discutibile in questi testi? A mio avviso molte cose, ad iniziare dalla terminologia utilizzata perché, nel tentativo di cercare nuovi percorsi semantici che evidenziassero il carattere innovativo del prodotto, si è peccato di imprudenza. Infatti, l’insieme delle azioni mirate a conservare e migliorare i boschi italiani – come enunciato nell’art. 1, Principi – nella prima bozza della legge viene definito “Gestione attiva” della foresta. Subito dopo viene spiegato che la “Gestione attiva” non è altro che il complesso dei tagli possibili. Poi, forse anche sull’onda delle proteste, ci si rende conto che l’espressione “Gestione attiva” non è la più conveniente e si scrive che “gestione attiva delle foreste” è espressione equivalente a “gestione sostenibile delle foreste”. Ora, premesso che il vocabolario italiano non agevola tale equivalenza, io ritengo che si sia commesso un errore di fondo. Le modalità di taglio del bosco (la cosiddetta gestione attiva secondo il TUFF) sono uno degli oggetti principali della selvicoltura, scienza empirica che nasce dall’esigenza di guidare gli interventi di prelievo legnoso dal bosco senza degradare il medesimo, anzi garantendone la perpetuazione. La selvicoltura, che raccoglie un plurisecolare patrimonio di esperienze, si pone proprio l’obiettivo di trarre un utile dalla foresta danneggiandola il meno possibile ossia assicurando la conservazione dell’efficienza dei meccanismi che ne regolano gli equilibri vitali. In altri termini, la selvicoltura è di per sé sostenibile e non può essere altrimenti. Chi non pratica una selvicoltura sostenibile, ossia la selvicoltura tout court, non è un forestale, ma un incompetente di madre culturale ignota. D’altra parte, il famigerato aggettivo “sostenibile”, nasce e può trovare applicazione solo in ambiente economico e industriale, lì dove si continua ad evocare il famoso quanto ambiguo “sviluppo sostenibile”. Non per nulla, l’aggettivo “sostenibile” non è stato adottato nel mondo delle scienze d base e di quelle che si riferiscono agli organismi viventi. Non esiste certamente una matematica o una fisica sostenibile, ma nemmeno una biologia sostenibile e nemmeno una medicina e chirurgia sostenibili. Immaginate una “clinica oculistica sostenibile”; a uno che per sbaglio va in una clinica oculistica che non reca la dicitura sostenibile che fanno? Gli cavano un occhio? Cerchiamo quindi di essere più precisi e coerenti altrimenti ci facciamo male da soli. Di recente ho sentito parlare addirittura di corsi di laurea in Gestione Sostenibile delle Foreste. Ma perché? Esistono in qualche università italiana corsi di laurea in Gestione Insostenibile delle Foreste? Non capisco davvero cosa si voglia intendere. La selvicoltura, quella con la S maiuscola, ancorché finalizzata alla produzione legnosa, non può non essere sostenibile e di conseguenza il vero forestale conosce solo la gestione sostenibile della foresta. Punto.
Non posso e non voglio dilungarmi, perché il tempo non lo consente, sui tanti altri aspetti che fanno divergere il vecchio pensiero forestale da quello più giovanile, ma non posso evitare un accenno ai cosiddetti servizi ecosistemici ai quali sia il TUFF che la Strategia Forestale Nazionale fanno ampio riferimento. Negli anni Settanta si parlava di tre funzioni del bosco: produttiva, protettiva e culturale-ricreativa. Adesso queste funzioni sono state addirittura suddivise in sottocategorie e si parla di almeno quattrodici tipologie di servizi ecosistemici. Dopodiché si offrono dei suggerimenti per gestire il bosco in modo che esso possa garantire questi servizi. Ora, sorvolando anche sul fatto che il bosco non è nato per erogare servizi, agli esperti che si sono impegnati nella stesura di questi testi è sfuggito, a mio parere, che l’ecologia e la stessa termodinamica avvisano che l’insieme dei servizi ecosistemici può essere fornito solo da un ecosistema integro. Tanto più è perturbato il bosco, tanto meno può risultare servizievole. Ciò significa che sarebbe opportuno approfondire l’argomento per arrivare a produrre un abaco che metta in relazione lo stato della foresta con gli eventuali ecoservizi che la stessa può erogare perché la generalizzazione può essere fuorviante. Infatti, gli ecoservizi offerti da un ceduo a turno breve sono ben pochi, almeno così credo.
Il problema di fondo, comunque, è che dopo tanti anni di evoluzione positiva delle idee sulla natura degli ecosistemi forestali e del rapporto uomo-bosco, si è tornati ad una visione di tale rapporto che considera l’uomo soggetto esterno e dominante, tanto che tocca sentire nuovamente circolare, anche in ambienti universitari, la fandonia secondo cui “il bosco ha bisogno dell’uomo” perché senza la selvicoltura il bosco muore. E il paradosso è che tutte le indicazioni fornite dal TUFF e dalla Strategia Forestale Nazionale non portano, come volevano i vecchi forestali, verso un incremento della complessità – che forse potrebbe richiedere l’intervento dell’uomo – ma verso una semplificazione sempre maggiore dei soprassuoli. La forma di governo prevalente sta tornando ad essere il ceduo perché i popolamenti invecchiati non vengono convertiti a fustaia, i turni si accorciano, le superfici assoggettate al taglio diventano più ampie e anche la lotta agli incendi boschivi ormai si risolve prima di tutto in nuovi tagli, una delle principali declinazioni della recentissima quanto aberrante selvicoltura “preventiva”!
Questa è, a mio avviso, la più triste e pericolosa conclusione di questa vicenda: per questo tipo di gestione attiva e preventiva del bosco basta un taglialegna, il forestale non serve più. Qualcuno dirà che questo è il futuro di tutte le professioni, compreso l’intero mondo della scienza. È vero, come stiamo già osservando, il lavoro del ricercatore non servirà più perché verrà sostituito dall’intelligenza artificiale. Nel frattempo, però, mi piacerebbe si usasse ancora l’intelligenza naturale.
- Molto devo anche al prof. Raffaello Giannini, all’epoca il più giovane Ordinario di Selvicoltura d’Italia, che, per far capire lo spirito del tempo, era anche il Delegato regionale del WWF per la Puglia.

da Valentina Venturi | 21 Lug, 2021 | Biomasse, Energia, Foreste
La Direttiva europea sulle energie rinnovabili non protegge il clima, le foreste e la salute umana
La Forest Defenders Alliance, gruppo di associazioni che proteggono le foreste di cui fa parte l’italiana GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane, esprime forte delusione per quanto emerso nelle bozze della Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED). Nonostante la forte opposizione di oltre 100 associazioni, di molti scienziati e di oltre 250mila cittadini, la Commissione Europea continua a promuovere la combustione del legno delle nostre foreste per produrre energia.
Parte del pacchetto “Fit for 55”, la revisione della direttiva dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione del 55% delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
La combustione di biomasse forestali è fortemente controversa perché emette più CO2 per unità di energia rispetto ai combustibili fossili, e gli stessi scienziati della Commissione Europea hanno riconosciuto che le foreste ricrescono troppo lentamente per compensare le emissioni causate dalla combustione del loro legno nel lasso di tempo che l’Europa si è data per il contenimento delle emissioni.
La scienza ha da tempo lanciato l’allarme: l’intensificarsi dei tagli boschivi per la produzione di biomasse a uso energetico sta danneggiando gravemente le nostre foreste, e gli scienziati chiedono di cambiare lo status delle biomasse forestali all’interno della direttiva europea, smettendo di considerarle una fonte rinnovabile.
Le associazioni temono che la nuova direttiva non riduca la pressione e lo sfruttamento intensivo delle foreste, come invece sarebbe indispensabile fare per permettere il ripristino degli ecosistemi e la mitigazione del cambiamento climatico, e che la prolungata dipendenza dalla combustione di legno non consentirà all’UE di ridurre le emissioni climalteranti.
Le modifiche della nuova direttiva rispetto a quella precedente sono:
- Gli stati membri della UE non potranno più dare incentivi per l’utilizzo a scopo energetico di legname di qualità, ceppaie e radici. Ma, secondo quanto dichiarato dalla stessa Commissione Europea, questi materiali costituiscono solo una piccola parte delle biomasse forestali utilizzate per la produzione di energia
- A partire dal 2027, gli stati membri non potranno più dare incentivi a impianti a biomasse forestali che producano esclusivamente energia elettrica, a eccezione delle centrali che si trovano in regioni particolarmente dipendenti dai combustibili fossili, o che utilizzino sistemi di cattura e stoccaggio della CO2. Il provvedimento però consente di continuare a bruciare biomasse forestali all’interno di vecchie centrali a carbone, in particolare nei paesi europei fortemente dipendenti dal carbone.
- La Commissione Europea adotterò un atto delegato sull’applicazione del principio a cascata delle biomasse, e su come ridurre l’utilizzo di legname di qualità per la produzione di energia. Si tratta di un passo nella giusta direzione, che riconosce l’importanza di dare priorità agli utilizzi nobili del legno rispetto alla combustione per produzione di energia, ma si tratta solo di un piccolo passo, in quanto circa metà del legno prodotto in europa viene bruciato a scopi energetici, e le modifiche alla direttiva non fanno nulla per affrontare questo problema
- Cambiano i criteri di sostenibilità della direttiva RED, che nella revisione chiedono che gli interventi di taglio tengano in considerazione il mantenimento la qualità del suolo e la biodiversità, evitando il prelievo di ceppaie e radici, salvaguardando le foreste primarie, evitando la conversione da foresta a piantagione di alberi, minimizzando i tagli a raso estensivi e incoraggiando il rilascio di legno morto sul sito di taglio. Queste direttive, però, riguardano solo una piccola parte del legno bruciato per scopi energetici, in quanto le foreste primarie costituiscono solo il 3% delle foreste europee, mentre le ceppaie e le radici già adesso raramente vengono utilizzate per la produzione di energia.
- La nuova direttiva impone criteri di sostenibilità alle centrali al di sopra di 5MW, soglia che prima era fissata a 20MW. Purtroppo, questi criteri di sostenibilità non affrontano il problema centrale, ovvero che la raccolta e combustione del legno per produrre energia aumenta le emissioni e compromette le foreste. Mentre la strategia europea per la biodiversità chiede di ridurre lo sfruttamento delle foreste, nessuna delle modifiche proposte alla RED va nella direzione di una riduzione della raccolta del legno. Al pari della versione precedente della direttiva, il nuovo documento persiste nel sostenere che la combustione di biomasse forestali riduce le emissioni in confronto all’utilizzo dei combustibili fossili, ignorando quanto affermato dagli stessi scienziati della Commissione Europea.
L’aumento della quota di energia rinnovabile a scapito delle foreste è un errore di proporzioni globali. Quando la UE sostiene di ridurre l’utilizzo di combustibili fossili e le emissioni, ma brucia sempre più foreste, l’unico risultato è l’aumento delle emissioni e il deterioramento delle foreste europee.
È tragico che la Commissione Europea non abbia colto l’opportunità di fare una riforma significativa della sua politica sulle biomasse. Il rifiuto dei politici europei di riconoscere i fatti scientifici sull’utilizzo delle biomasse forestali è paragonabile al negazionismo sul cambiamento climatico.
La Commissione ha compreso che gli incentivi alla combustione di legname di qualità vanno ridotti. Ora la stessa logica deve essere applicata a tutta la biomassa forestale, in quanto la combustione di tutte le qualità di legno aumenta le emissioni su lassi di tempo rilevanti per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico. L’industria delle bioenergie sta facendo enormi guadagni a spese dei contribuenti europei, che pagano inconsapevolmente per il taglio e la combustione degli alberi e la distruzione delle ultime aree verdi. Significativa in questo senso è la lettera inviata pochi giorni fa dalle associazioni italiane del settore delle bioenergie ai ministri Patuanelli e Cingolani, che, criticando la Strategia Forestale Europea, sostiene che la filiera legno-energia sia sostenibile e contribuisca alla lotta contro il cambiamento climatico e chiedendo un maggiore spazio (e, presumibilmente, maggiori incentivi) per le bioenergie. È completamente da respingere la richiesta delle associazioni del settore delle bionergie di considerare la gestione forestale una questione di pertinenza nazionale. Il riscaldamento climatico e la perdita di habitat e biodiversità sono fenomeni globali e che impongono di ragionare a livello globale.
Qualunque tipo di legno venga bruciato, lo sfruttamento intensivo delle foreste per la produzione di energia danneggia gli ecosistemi forestali e la loro biodiversità. La revisione della direttiva RED vieta i tagli nelle foreste primarie, ma dato che queste ultime costituiscono solo il 3% del patrimonio forestale europeo, la direttiva lascia senza protezione il restante 97%.
In un momento di crisi climatica e rapida estinzione delle specie, non è più possibile tollerare altri passi falsi nella gestione delle foreste e nella produzione di energia. La rapida estinzione di moltissime specie, molte non ancora adeguatamente studiate, è letale per l’umanità al pari del cambiamento climatico. Se non ci concentriamo da subito sulle energie realmente rinnovabili come il sole e il vento, ma continuiamo a distruggere foreste, perderemo per sempre un numero inaccettabile di habitat e specie, e con loro tutti i benefici ecosistemici che questi offrono all’umanità.
Le foreste sono molto di più che alleate contro la crisi climatica. La loro presenza è fondamentale per la nostra salute: le foreste mantengono pure l’acqua che beviamo e l’aria che respiriamo. La triste realtà è che finora le politiche europee hanno incoraggiato la combustione del legno delle nostre foreste e accelerato il deterioramento del patrimonio forestale europeo. Per rimediare ai danni fatti è necessaria una riduzione dello sfruttamento delle foreste per la produzione di legname, ma la revisione della direttiva RED non porterà a questo.
Le foreste non sono rinnovabili, sono ecosistemi che possono essere ripristinati ma non ricreati. Si possono piantare alberi, ma non si possono ricreare foreste. Abbiamo bisogno di bruciare meno legna e di meno monoculture forestali.
Un modo efficace per ridurre la conversione delle foreste in monoculture è rimuovere gli incentivi che stanno trainando la domanda di legname per le centrali a biomasse forestali. Invece, la Commissione Europea sceglie di supportare sia l’offsetting che l’energia dalla combustione di biomasse forestali.
“Fit For 55” non protegge a sufficienza le foreste e non contrasta in modo adeguato il cambiamento climatico. Abbiamo un bisogno disperato di politiche oneste che includano tutte le emissioni nelle nostre statistiche. Chiediamo ai membri del Parlamento Europeo di essere all’altezza della situazione quando toccherà a loro votare.
Le biomasse forestali pongono inoltre gravi problemi di inquinamento dell’aria e costituiscono una minaccia alla salute umana. La combustione di legna produce grandi quantità di polveri sottili, che secondo le stime uccidono circa 400mila europei ogni anno. La combustione di legno emette anche carbonio, azoto, metalli pesanti, mercurio e furani. Questo tema è stato completamente ignorato nella proposta di modifica della direttiva RED.
È quindi vitale che l’Europa riduca rapidamente la sua dipendenza dalle foreste per produrre combustibile, rimuovendo le biomasse forestali dalle energie rinnovabili. Le associazioni si appellano al Consiglio Europeo e al Parlamento Europeo affinché fermino lo sfruttamento intensivo delle foreste a scopi energetici e si assicurino che i target di energia pulita vengano raggiunti tramite tecnologie realmente pulite e a basse emissioni.

da Valentina Venturi | 1 Giu, 2020 | Biomasse, Energia, Foreste, Inquinamento, Salute
L’associazione GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane appoggia la richiesta portata avanti da diverse associazioni di sospensione della riapertura della centrale a biomasse di Mercure. La megacentrale collocata nel Parco Nazionale del Pollino brucia 350.000 tonnellate di legno vergine all’anno (frutto del taglio di centinaia di migliaia di alberi) per produrre energia elettrica: una modalità di produzione di energia che l’Italia deve abbandonare per quattro importanti ragioni.
In primis, bruciare biomasse forestali accelera il riscaldamento globale: le energie da biomasse legnose sono più climalteranti persino delle energie fossili poiché, a parità di energia prodotta, emettono il 150% di CO2 rispetto al carbone e il 300% rispetto al gas naturale (da “Letter From Scientists To The Eu Parliament Regarding Forest Biomass” del gennaio 2018), mentre il riassorbimento di equivalenti quantità di CO2 da parte di nuovi alberi richiederà molti decenni: un tempo che non abbiamo a disposizione. Il taglio di un numero così elevato di alberi va ad aggravare il riscaldamento globale di cui una delle concause principali è proprio la deforestazione. Per rimuovere la CO2 accumulata abbiamo bisogno di grandi alberi e delle foreste vergini, che la assorbono oltre 50 volte in più rispetto ai nuovi alberi e alle piantagioni.
Secondo, la combustione di biomasse forestali presenta un grave rischio per la salute dei cittadini, in particolare in una zona come la Valle del Mercure, dove i fumi di combustione ristagnano a lungo a causa del fenomeno dell’inversione termica. La combustione di tutte le biomasse legnose, secondo i dati ufficiali dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) e di ISPRA, per la sola emissione in atmosfera di PM2,5, causa in Italia circa 20.000 morti premature ogni anno, senza contare le patologie dovute alle emissioni di inquinanti emessi nella combustione del legno (arsenico, mercurio, diossina, furani, IPA…). L’Italia detiene il triste record in Europa per morti premature derivanti dalla cattiva qualità dell’aria.
Terzo, l’utilizzo delle biomasse legnose come fonte di energia minaccia le foreste. Il patrimonio boschivo italiano è ormai sfruttato intensivamente e ben oltre i limiti di rigenerazione dello stesso. Un disastro ecologico che compromette gravemente gli ecosistemi forestali, privando le specie animali e vegetali del loro habitat, e che ha effetti anche sulla popolazione, in quanto la conservazione del patrimonio forestale è essenziale per la stabilità del suolo e la regimazione delle acque.
Quarto, il rapporto presente tra la distruzione di habitat naturali – soprattutto forestali – e l’innesco di epidemie causate dalla migrazione degli animali selvatici cacciati dal loro habitat. Virus di cui gli animali sono portatori possono fare il salto di specie e infettare l’uomo. È avvenuto con Hersa in Australia, arrivata dai pipistrelli, che si è diffusa prima tra i cavalli per poi passare all’uomo; con Ebola in Africa, dove i cercatori d’oro hanno disturbato la foresta casa di diverse specie di primati; con la malattia di Lyme negli USA, dove la scomparsa dei boschi ha decimato i predatori degli artropodi e causato un forte aumento delle zecche che trasmettono la malattia all’uomo; e in tantissimi altri casi riportati nella bibliografia scientifica e nell’ormai noto best seller Spill Over di David Quammen.
La produzione di energia da combustione di biomasse legnose non può quindi essere considerata energia pulita, non dovrebbe poter usufruire di generosi incentivi economici, e andrebbe abbandonata al più presto per la salute del pianeta, dei cittadini e per la nostra sicurezza sanitaria e sociale. GUFI è per un utilizzo razionale e sostenibile del legno, ottenuto da selvicoltura ecologica e in boschi destinati all’uopo, e per qualsiasi prodotto in cui il carbonio in esso contenuto resti allo stato solido.

da Livia Schirone | 14 Apr, 2020 | Biomasse, Clima, Difesa Foreste, Energia, Foreste, Inquinamento, Salute
ISDE Italia – Medici per l’Ambiente e GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane chiedono alle istituzioni di non autorizzare la ripresa dei tagli boschivi, un’attività che nel caso delle latifoglie è anche fuori tempo massimo: è ormai primavera e i tagli nei boschi di latifoglie sono vietati per consentire alle piante il periodo vegetativo. Aperta una petizione su Change.org.
Roma, aprile 2020 – GUFI e ISDE chiedono alle istituzioni di non accogliere la richiesta avanzata da CONAIBO (Coordinamento nazionale delle imprese boschive), AIEL (Associazione italiana energie agroforestali), Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) e alcuni Comuni montani di riaprire le attività di taglio degli alberi in deroga alla quarantena, e hanno aperto una petizione sul sito Change.org per chiedere il sostegno dei cittadini che hanno a cuore l’ambiente e la salute pubblica.
Le attività forestali sono infatti ferme in quanto considerate non necessarie, e nel momento in cui l’Italia ripartirà sarà concesso solo, fino al prossimo inverno, il taglio dei boschi di conifere. Questo perché nei boschi di latifoglie (querce, faggi, carpini…) non è concessa l’attività di taglio durante il periodo vegetativo, cioè quando le piante hanno già messo le foglie. Tagliare le latifoglie in primavera, tramite la tecnica del ceduo che rimuove il tronco dell’albero lasciando solo un ceppo da cui nascono nuovi polloni, le danneggerebbe gravemente con evidenti ricadute sugli ecosistemi. Il taglio delle foreste di conifere (pini, abeti) è invece concesso tutto l’anno, perché nel loro caso la tecnica del ceduo non si può utilizzare e la riproduzione avviene unicamente tramite seme.
Le associazioni dei tagliatori non stanno quindi chiedendo solo di violare la quarantena a cui sono sottoposte tutte le altre aziende, ma anche di poter violare la legge che protegge i boschi di latifoglie, tagliando a primavera ormai giunta: quest’anno, infatti, la stagione risulta particolarmente anticipata, a seguito di quello che è stato l’inverno più caldo di sempre in Europa (3,4 gradi in più rispetto alla media del periodo).
Perché questo accanimento?
È importante ricordare che in Italia è in corso da anni un vero e proprio assalto alle foreste, viste non come bene prezioso per il pianeta, per la salute dei cittadini e come arma contro il riscaldamento globale, ma unicamente come fonte di energia. Il proliferare in Italia di centrali a biomassa, che bruciano legno per produrre energia elettrica, ha scatenato una vera e propria corsa al taglio. Le nostre foreste, che per mera superficie sono in aumento, vengono gravemente impoverite e compromesse da continui tagli che interessano gli alberi più grandi: un diradamento che, se lascia intatta la superficie della foresta, di fatto la spoglia quasi completamente riducendola a pochi alberi giovani e sottili, distanti tra loro. Una devastazione evidentissima anche a un occhio non esperto (si allega foto di una foresta governata a ceduo).
GUFI e ISDE ricordano che bruciare il legno provoca maggiori emissioni di CO2 e di polveri sottili persino rispetto all’utilizzo dei combustibili fossili, con ricadute drammatiche in termini di contrasto al cambiamento climatico e di impatto sulla salute. Le biomasse forestali non possono essere considerate una fonte rinnovabile di energia: anche piantando un albero in sostituzione di quello tagliato, questo impiegherà anche un secolo ad assorbire le emissioni di quello abbattuto, sempre ammesso che non venga tagliato prima – un lasso di tempo che non ci è concesso prenderci nella lotta al riscaldamento globale e per la conservazione della biodiversità. Non a caso, due anni fa ben 784 scienziati hanno scritto al Parlamento Europeo per segnalare che usare legna come combustibile accelererà il cambiamento climatico, mentre sempre più studi rivelano l’importanza delle foreste mature e intatte nella lotta al riscaldamento globale. Inoltre, come evidenziato da un comunicato stampa del WWF a marzo, esiste uno strettissimo legame tra pandemie e danni all’ecosistema.
La richiesta delle associazioni dei taglialegna di riprendere le attività in violazione della quarantena e addirittura di prolungare il taglio delle latifoglie anche durante il periodo primaverile è causato dal desiderio di placare la fame insaziabile delle centrali a biomassa, per le quali il solo legno di conifera tagliato al termine della quarantena parrebbe non sufficiente. Eppure, come fatto notare dagli stessi promotori della richiesta di deroga alla quarantena, rimangono a terra milioni di tronchi schiantati dalla tempesta Vaia, che stanno venendo acquistati da imprese austriache proprio per produrre legna da ardere. Il recupero del legno schiantato dalla tempesta (che giace lì da moltissimi mesi, quindi non si comprende l’urgenza) può essere autorizzato con un provvedimento ad hoc, senza riprendere i tagli su tutto il territorio nazionale. Trattandosi di conifere, inoltre, il prelievo di questi alberi potrà riprendere immediatamente dopo la fine della quarantena, anche se andrà fatto con oculatezza per evitare l’erosione del terreno e il conseguente rischio idrogeologico.
Non vi è inoltre alcun rischio di esaurimento a breve termine delle scorte di legno, dato che quelle per il prossimo inverno sono già state approntate e non sarà eventuale legna raccolta ora, ancora verde, ad aumentarle. Inoltre in questo momento sono chiusi alberghi di montagna, ristoranti, rifugi, pizzerie ed altri esercizi che fanno grande consumo di legna da ardere: il fabbisogno di legna nell’ultimo mese è crollato.
Le imprese e le loro associazioni lamentano inoltre la necessità di produrre imballaggi di legno (pallets) per i settori fondamentali. I pallets però vengono prodotti perlopiù con il legno delle conifere: non c’è quindi ragione di tagliare le latifoglie in deroga alle norme ambientali. Inoltre i pallet sono riutilizzabili. Il settore agroalimentare non utilizza pallets ma contenitori di plastica, e lo stesso vale per i prodotti farmaceutici. Non ci sono quindi attività essenziali che abbiano bisogno di un’immediata produzione di pallets.
Inoltre è legittimo chiedersi in quali condizioni sanitarie le aziende di taglio vorrebbero far operare i loro lavoratori durante la pandemia: sono tristemente note le continue violazioni delle norme basilari di tutela dei lavoratori nel settore dei tagli boschivi, dove è inoltre ampiamente diffuso il lavoro nero.
In conclusione, GUFI e ISDE ritengono che non vi sia alcuna ragione per ritenere il taglio di alberi come attività necessaria che meriti una deroga durante la quarantena; che eventuali (e da dimostrare) necessità di legname possano essere soddisfatte utilizzando il legno schiantato dalla tempesta Vaia tramite un provvedimento ad hoc, che non includa le altre foreste sul territorio italiano; e che la richiesta di riaprire il taglio nei boschi di latifoglie in deroga alle leggi a protezione dell’ambiente sia irricevibile.
GUFI e ISDE invitano tutti i cittadini che hanno a cuore la salute e l’ambiente (e conseguentemente la propria) a firmare la petizione “Taglialegna #stateacasa” sul sito Change.org all’indirizzo: http://chng.it/g9zHLWXc
CONTATTI
Valentina Venturi – Ufficio stampa GUFI
Mail: press@gufitalia.it | Tel: 3403386920

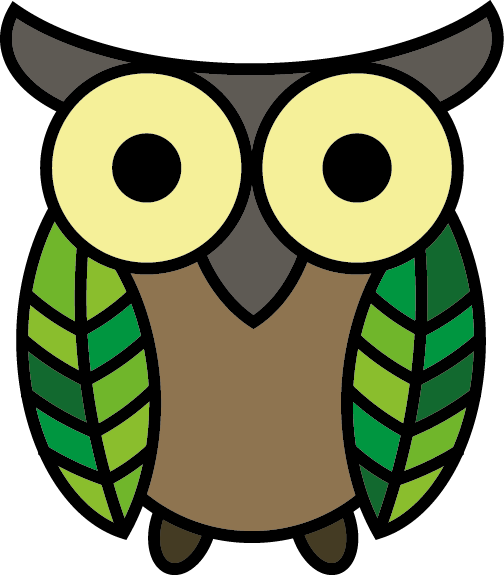




Commenti recenti